“Se volete che si creda a voi…io voglio che voi crediate a me”.
Sulla peste del buonsenso, l’eroe unico di Michele Cannaò danza d’immortalità imperitura.
“Contro la pusillanime mediocrità dell’automutilazione umanista sferra la propria lancia Michele Cannaò, con la sola strategia dell’arte e del suo grande sentimento. Nel suo ironico sorriso v’è l’accettazione completa del sacrificio, la lotta rivoluzionaria: unica contropartita per una rivendicazione del quotidiano dall’economia della vita.
Perché nel regno del quantitativo, la bontà è solo merce, una speculazione tradotta in cifre.
E il cuore di Quijote, in cifre, non vale niente. La morale capitalista del profitto, in una combinazione d’interferenze, si palesa ad uso del “rifiuto” nel diniego sdegnosamente borghese, nella vile e mendicante ingordigia, nell’avida mascherata dei compassionevoli.
Chi sono i compassionevoli? I “pastori di Dio”, tutti simili son tra loro nell’inchiodare l’uomo alla croce professando la dottrina del potere.
Una virtù che dona, quella che ci insegna Quijote, che disprezza i biasimi e disdegna la pietà; che sfugge la paura e libera dal dolore, imperturbabile nella volontà e pudica nella gioia. Una virtù che libera: la volontà ci libera”.
Il 20 Aprile nella grande sala a scacchi della Posteria di Milano, 13 figli della propria opera, accolgono colui che di Quijote ne incarna vizi e virtù, l’antipoeta Michele Cannaò: nobile pittore della casata dei “Folli dissidenti”; elegante uomo dalla retta fede nell’ideale di bellezza, d’amore e di giustizia sociale; quintessenza dei cavalieri erranti. Sono le diciotto e quarantasette minuti di un tempo “senza misura né calcolo” in un pianeta in sincronizzazione sbagliata. É l’ora di urlare il proprio disprezzo al lento degradarsi dell’uomo, schernire i dispotici e premiare i buoni.
Non c’è finzione signori! Ma coerenza d’intenti e autodeterminazione.
Vestito di nero dall’oscurità primordiale, nell’aspetto sensuale della mistica universale, flemmatico di piede e impavido di spirito, fa la sua comparsa Quijote. Il prode compagno ha per elmo un fez di velluto bordeaux Boemia, del colore del vino amaro e vittorioso cantato da Baudelaire in “I Fiori del male”, simbolo del propizio succedersi degli incontri verso i popoli d’oriente; per schiniera indossa un avanzo di rame in lastra incisoria, su cui appare incava, una foglia di vite nel suo sfavillo di luce assimilata in dono alla terra; per rinforzare l’aura, sul plesso cardiaco oscilla lucido e opalescente un monile in madreperla, ottenuto barattando con una conchiglia la paura stessa. Un elisir di acqua di gemme irradia il suo canto mentre destreggiando di ludico furore l’alabarda seicentesca, spezza le armi con il cuore.
“Nello spazio di un mondo che dispera la sua terra al margine dell’occhio che contempla”, dalla voce epico-narrativa dei cantori popolari, su una musica indoeuropea di armena contaminazione, “la lingua gallo-italica accompagna assonante gli archetipi del femminile” in un canto riportato da Vincenzo Consolo nel “Lunaria” e la cui fonte attesta il nome della sanfratellana Serafina Di Paola. “Tale s’introduce, in un sensuale monologo riflesso, ritratto ineluttabile di ogni cambiamento, l’inno alla luna”. Il costante rimando all’altro da sé sancisce il “rapporto” nella sua più alta espressione di reciprocità e d’azione sino al superamento dello stesso monologo, che nel divenire compositivo dissolve sempre più la controversia scolastica fra reale e nominale, esistenza e missione.
Così va’ errando il triste mancego…fluttuante, caldo, tenebroso, graffiante e temerario; disorientato e cieco per l’esterno. Da lui divampa il suono come fiamma e sebbene nasce solo a poco a poco, la melodia divampa nelle sue figurazioni, nella fusione degli accordi, nell’inconfondibilità dell’avvicinamento a chi, simultaneo e in assonanza, lo accompagna in un’autentica perfezione artistica.
Felice Zaccone con le sue partiture evocative e struggenti d’ineffabile bellezza, segue la trama vocale con note cromatiche e traforate, tese e delicate nell’amore, assordanti e stridenti nel malinconico torpore. Ma ogni durezza ormai appartiene al passato, conclusa in modo completo e decisivo. D’ora in poi non si può più essere infelici, l’esplosiva maturità si offre agli avvenimenti scalzando le menti incredule addensate nell’angoscia di una verità nascosta. Il bello si compone di festività nella problematicità della conoscenza estetica, non lasciandosi chiudere nell’orizzonte della linea storica.
Le prestazioni mimiche sono innalzate all’idealità di un orecchio interno che costruisce un’opera solenne e scherzosa, ardimentosa e fiera e che pur nella sconfitta appare vittoriosa.
Sì, vittoriosa! Perché non può che trionfare il chisciottismo quando la gloria si chiama utopia, quando agisce ribelle nell’intelligenza del cuore deviando le frottole sanciopanzesche e l’idiozia dei gentiluomini della Ragione nell’arrivismo delle loro cariche e nella celebrità degli onori. Lo scherno di Quijote si leva alto da una barricata mirabilmente inscenata nel suo fattuale riferimento alla “transtorica” Rivoluzione spagnola del 1936-39 nelle sue implicazioni internazionaliste, ma soprattutto nella dimensione tragicamente titanica di un’autonomia libertaria fra antifascismo e antiautoritarismo.
Caparbia appare la “resilienza” dell’artista Cannaò nell’intersezione immaginifica di una mente esiliata incedente a un fischio il proprio passo. È il fischio di quel vento che continua a ricordarci che c’è ancora una Primavera da conquistare ed è là che sorge il sole dell’avvenire.
Felicia Lo Cicero
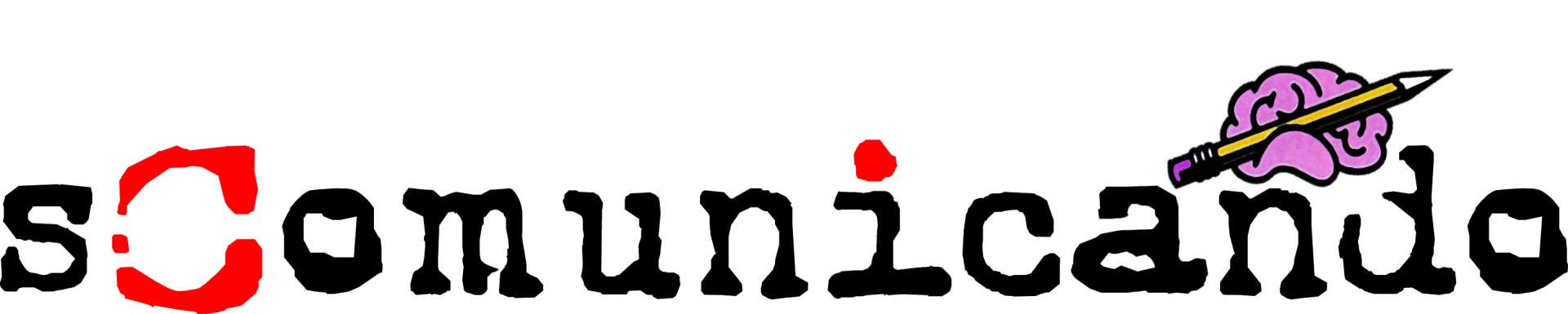







Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.