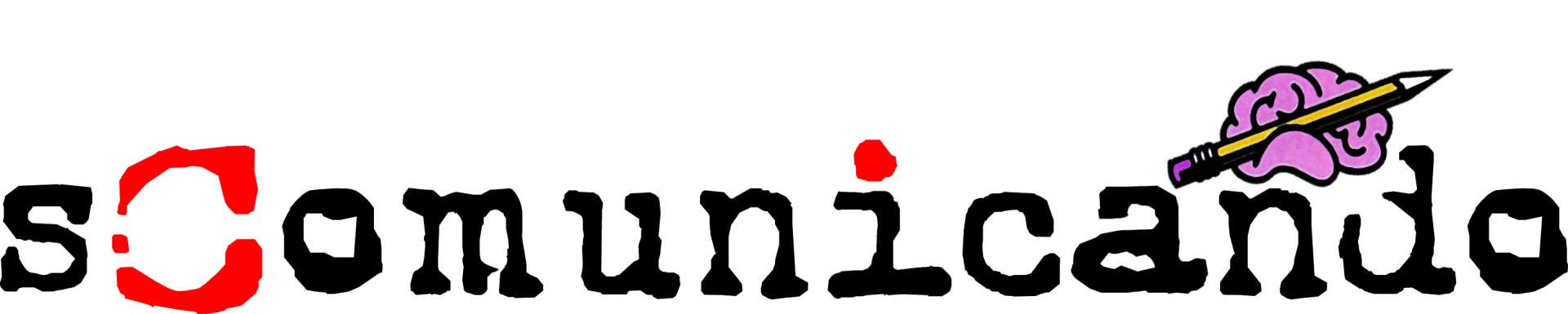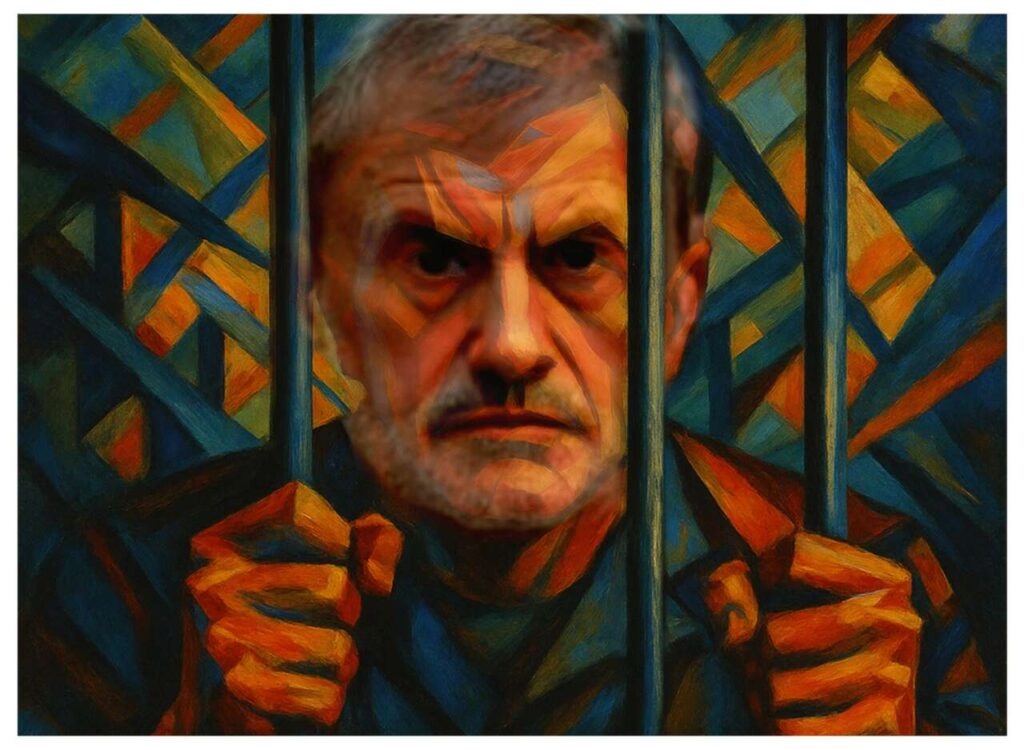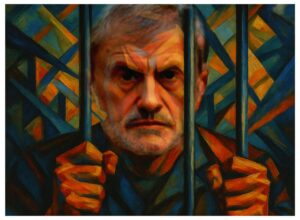quando l’inferno diventa comunità
Continuano le testimonianze da Rebibbia da parte di Gianni Alemanno. Altre tre lettere, tra morte, generosità e salvezza al braccio G8
Dentro il carcere più grande d’Italia, dove il caldo arroventa il cemento e il sovraffollamento stritola le vite, è successo qualcosa di raro: la vita ha avuto la meglio. È successo lunedì 30 giugno, quando un giovane detenuto libico ha tentato di togliersi la vita in isolamento, ma è stato salvato dalla prontezza e dalla generosità di compagni di cella e agenti penitenziari. Una scena che Gianni Alemanno, ex sindaco di Roma e oggi detenuto a Rebibbia, racconta con lucidità e commozione nel suo “Diario di cella”.
Un episodio che porta a galla, insieme a un barlume di umanità, tutta la drammatica realtà delle carceri italiane: 71 suicidi in cella nel 2024, già 38 nei primi sei mesi del 2025, uno ogni cinque giorni. Numeri che non fanno rumore, ma che gridano vendetta, come scrive Alemanno: «Chi muore in carcere spesso muore due volte: nella cella e nell’indifferenza collettiva».
La cronaca di un salvataggio
Quel pomeriggio di giugno, Kafi, 29 anni, è solo in una cella d’isolamento del braccio G8. Un isolamento che, racconta Alemanno, prosegue anche dopo la guarigione dalla scabbia per via della sua agitazione. Lutfim, un detenuto albanese, passando davanti allo spioncino, lo vede: appeso alle sbarre con il sangue che gli scende dalla gola. Scatta l’allarme. Fabio Falbo, “lo scrivano di Rebibbia”, corre giù per cercare le chiavi. Poi altri detenuti – Peppe, Francesco, Andrea – irrompono nella cella e sollevano il corpo. L’alto e forte Peppe riesce a tagliare il cappio. Il ragazzo è esanime, ma ancora vivo. Arriva l’infermiera Gloria, tampona la ferita, lo porta con altri detenuti in infermeria, lo rattoppa alla meglio e lo trasferisce al reparto medico per ulteriori cure.
Un intervento tempestivo, ma anche una scena surreale: poco dopo, è l’appuntato Giovanni, uno degli agenti intervenuti, a sentirsi male e a finire steso su un lettino, circondato da detenuti che lo confortano e gli offrono caramelle. «Solidarietà tra persone, al di là del ruolo, della divisa e della detenzione. Spirito di comunità tra due categorie di vittime del sovraffollamento e del caldo nelle carceri», scrive Alemanno.
Per questo ha chiesto al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di assegnare un riconoscimento a quei detenuti e all’infermiera che hanno salvato una vita.
Un inferno di cemento e caldo
Non è solo la disperazione a spingere molti detenuti verso il suicidio. È anche il contesto disumano in cui vivono. Il “Diario di cella” racconta con dettagli quasi scientifici l’effetto serra che si respira in quelle celle d’estate: al piano terra si sopravvive, ma al secondo piano, dove abita Alemanno, si arriva a 10 gradi in più per effetto del cemento armato senza coibentazione. L’“effetto forno” è amplificato dall’assenza di aria condizionata e dalla lentezza burocratica perfino per acquistare un ventilatore.
Celle sovraffollate, persone malate messe insieme a caso, anziani in condizioni pietose bloccati in carcere per settimane nonostante la concessione dei domiciliari. Tutto mentre la politica parla di nuove carceri prefabbricate che non basteranno nemmeno a coprire le nuove entrate. «La politica dorme (con l’aria condizionata)», scrive con amarezza l’ex ministro.
Una memoria lunga 46 anni
In questa cornice di disperazione e rabbia, Alemanno rievoca anche una memoria personale: la morte di Francesco Cecchin, militante di destra ucciso a 18 anni nel 1979. Un delitto rimasto impunito, che segnò la sua giovinezza e la sua militanza, e che ancora oggi lo accompagna come simbolo di ingiustizia. Dal ricordo di Cecchin e di altri compagni morti negli anni ’80, Alemanno trae la consapevolezza di come la violenza politica, l’indifferenza e la lentezza della giustizia abbiano segnato più di una generazione. «Non si può chiudere gli occhi perché non conviene vedere. Perché questo non è solo uno sbaglio, è una vergogna», scrive.
Una lezione per l’Italia
Le sue lettere, pur scritte da una cella, sono un atto d’accusa verso un sistema che tratta le carceri come discariche sociali, che dimentica non solo i detenuti ma anche gli agenti penitenziari. Un sistema incapace di vedere l’umanità che resiste, nonostante tutto, tra le sbarre.
La vicenda di Kafi e di chi lo ha salvato ci ricorda che la comunità carceraria è fatta di persone. Che la vita può prevalere sulla disperazione se si trovano mani tese, anche in un inferno di cemento. E che la politica, come conclude Alemanno, non può continuare a voltarsi dall’altra parte.
Un riconoscimento per quei detenuti sarebbe il minimo. Ma il vero riconoscimento sarebbe trasformare questa indignazione in riforme concrete. Perché chi muore in carcere non muoia anche nell’indifferenza di chi sta fuori.
da leggere
DIARIO DI CELLA 13. MORTE, GENEROSITÀ E SALVEZZA AL BRACCIO G8: COME È STATO EVITATO IL 39° SUICIDIO DI UNA PERSONA DETENUTA NEL 2025.
Rebibbia, 6 luglio 2025 – 187° giorno di carcere.
Lunedì 30 giugno, ore 10:30, Palazzo del Quirinale. Il Presidente Mattarella incontra i nuovi vertici del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria e approfitta dell’occasione per richiamare l’attenzione sulle drammatiche condizioni delle carceri italiane, ricordando in particolare la lunga serie di suicidi di persone detenute (e anche di agenti della penitenziaria). Il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, gli risponde a stretto giro sfogliando il solito libro dei sogni (fatti mentre dormiva con l’aria condizionata) con nuove carceri, penitenziari prefabbricati e luoghi di detenzione riservati ai tossicodipendenti.
Ore 15, Braccio G8 di Rebibbia. Lutfim, detenuto albanese di lungo corso, mentre passeggia nel corridoio del mio reparto al secondo piano, passa davanti alla cella d’isolamento dove è recluso Kafi, libico di 29 anni, messo in isolamento quando era malato di scabbia e lì lasciato anche dopo la guarigione da questa malattia, perché si agitava troppo.
Nonostante la porta sia chiusa, Lutfim nota qualcosa attraverso lo spioncino aperto. Si affaccia e vede Kafi appeso alle sbarre della finestra della cella con il corpo grondante di sangue. Si mette a urlare per chiedere aiuto, arriva Fabio Falbo (“lo Scrivano di Rebibbia”, con cui scriviamo tutte le nostre lettere alle istituzioni), si rende conto della situazione e corre al piano terra per cercare gli agenti con le chiavi della cella. Torna al secondo piano con il capoposto Luigi e l’appuntato Giovanni, che finalmente riescono ad aprire la cella, chiusa non solo con il cancello con le sbarre ma anche con il “blindo”, la porta di ferro con spioncino usata per l’isolamento. Irrompono dentro Fabio, Francesco, Andrea e, soprattutto, Peppe. Peppe è un ragazzo di un metro e novanta, testa calabrese da parte di padre e corpo da Ussaro da parte della madre austriaca. Tutti insieme sollevano il corpo di Kafi e Peppe, forte della sua altezza, riesce a tagliare il laccio delle scarpe con cui si era impiccato.
Il corpo ora giace per terra in una cella spoglia dove non c’è neanche un pezzo di carta, non respira, il sangue che esce copioso da un profondo taglio, che il tentato suicida si era inferto all’altezza della carotide. Fabio corre di nuovo al piano terra, dove c’è l’infermiera del braccio, trova Gloria, l’unica infermiera presente (una ragazza tosta dai capelli ricci, abituata a tenere a bada detenuti e fronteggiare emergenze). Si portano sopra una barella a braccio (in pratica un sacco di telo con sei manici), Gloria tampona la ferita alla carotide, cerca di rianimarlo, e tutti insieme, con altri due detenuti che si sono aggiunti (Massimo e Fabrizio), trasportano il moribondo in infermeria. Qui Gloria chiama il medico di guardia che sta al Braccio G6 (infermeria centrale), che si rifiuta di venire e chiede invece che Kafi sia portato da lui con tanto di “libro medico” (viva la burocrazia italiana). Provvedono Fabio e Gloria, accompagnati dal capoposto perché altrimenti i detenuti – vivi o moribondi – non potrebbero uscire dal braccio.
Al G6, finalmente, il medico pone fine all’agonia di Kafi con gli opportuni farmaci e sei punti di sutura alla gola. Ma la sua tragedia non finisce qui: nella sera Kafi estrae due lamette che aveva tenuto nascoste in bocca sotto le guance e si taglia di nuovo le braccia e il torace per un atto di estremo autolesionismo, che però non diventa tentato suicidio perché è già ricoverato in infermeria, dove si trova tuttora in isolamento.
Nel frattempo al Braccio G8, Giovanni, l’appuntato che aveva aperto la cella di Kafi, si è sentito male, è svenuto ed è stato portato a braccia anche lui all’infermeria. Così, quando un Fabio Falbo, sudato e prossimo al collasso, mi viene ad avvertire di quello che è successo e vado in infermeria a vedere la situazione, mi trovo davanti ad una scena surreale e toccante: Giovanni in divisa, steso sul lettino e circondato da un gruppo di detenuti che lo confortavano. Uno gli tiene la mano, l’altro gli trova una caramella per fronteggiare il calo di zuccheri, un altro gli parla all’orecchio. Solidarietà tra persone, al di là del ruolo, della divisa e della detenzione. Spirito di comunità tra due categorie di vittime del sovraffollamento e del caldo nelle carceri (e dell’indifferenza della politica): le persone detenute e quelle con la divisa della penitenziaria.
Ho scritto al Presidente Mattarella chiedendo che tutti coloro che hanno partecipato ai soccorsi e sventato in extremis questo suicidio, venga dato un riconoscimento ufficiale: Fabio, Giuseppe detto Peppe, Francesco, Andrea, Massimo, Fabrizio e Lutfim, con l’infermiera Gloria. Mi risponderà? Non ha importanza, l’importante è che continui a sollecitare la politica a svegliarsi e a fare qualcosa di serio.
Nel frattempo un’altra persona detenuta, Mohamed, egiziano di 33 anni, malata di scabbia, è stata chiusa in isolamento al secondo piano, senza niente in cella, senza televisore, senza ventilatore…
Gianni Alemanno.
DIARIO DI CELLA 12. ARRIVA IL MOMENTO PIÙ DIFFICILE: IL CALDO ARROVENTA IL SOVRAFFOLLAMENTO.
MA LA POLITICA DORME (CON L’ARIA CONDIZIONATA).
Rebibbia, 29 giugno 2025 – 180° giorno di carcere.
Se uno studente volesse sperimentare in modo evidente il significato del concetto fisico di “gradiente termico” dovrebbe venire qui a Rebibbia e spostarsi dal piano terra fino al secondo e ultimo piano.
Al piano terra, grazie all’umidità che viene dal suolo, il caldo estivo è ancora sopportabile, ma salendo per le scale che portano al secondo piano, la temperatura aumenta progressivamente di almeno un paio di gradi per ognuna delle quattro rampe che compongono queste scale. Per cui, quando si arriva in cima, ci sono quasi dieci gradi di temperatura in più. Se poi, come il sottoscritto, si abita nell’ultima cella del corridoio, quella esposta al sole non solo sul soffitto ma anche su due lati, “l’effetto forno” è una realtà.
Il carcere di Rebibbia è stato costruito negli anni ’70 quando tutte le strutture erano in cemento armato privo di coibentazione e quindi perfette per trasmettere il freddo durante l’inverno e il caldo durante l’estate. Ma d’inverno ti metti due coperte, d’estate cosa fai? Assenti, ovviamente, impianti di condizionamento nelle celle e nei corridoi, i detenuti girano in versione spiaggia (per non dire altro), si buttano in branda come se fossero su un lettino da spiaggia (per non fare altri paragoni), si inventano miserevoli trucchi per contrastare qualche grado di temperatura.
Luciano, il nostro anziano di cella, esperto muratore e capo mastro, ha elaborato un complicato sistema di vasi comunicanti per distribuire l’acqua corrente per rinfrescare bottiglie d’acqua e un poco l’ambiente. Poi ci sono i ventilatori, quelli antichi da tavolo, non più di due a cella, che – se hai i soldi sul conto corrente – puoi comprare dall’Amministrazione. Noi ne abbiamo anche uno solo, perché quello che ho comprato io non mi viene consegnato da quindici giorni, visto che l’Amministrazione, troppo impegnata a organizzare pletorici eventi sportivi e d’intrattenimento dentro il carcere (molto utili a fare bella figura nei TG, di scarso interesse per le persone detenute), non riesce a dare impulso neanche alle più semplici pratiche burocratiche, come comprare qualche ventilatore o qualche medicina, né riesce a nominare il Caporeparto che nel nostro Braccio manca da qualche settimana (da quando se n’è andata la grandissima Cinzia), così come avviene anche nel problematico Braccio G11.
Questo surdo di caldo rovente, che ci porteremo addosso per i prossimi mesi, si aggiunge alla vergogna del sovraffollamento. Ma la politica dorme (con l’aria condizionata) e non si accorge che già a giugno siamo arrivati a cinque proteste carcerarie in giro per l’Italia, errore clamoroso (oggi anche reato, dopo il decreto sicurezza) da parte dei detenuti, follia da cervelli surriscaldati e da persone accatastate una sull’altra.
Come ho detto più volte, qui al braccio G8 di Rebibbia siamo ai “Parioli” delle carceri laziali, ma anche qui, senza un Caporeparto, avvengono cose che non dovrebbero avvenire. Come una persona malata di scabbia che viene messa dentro il nostro reparto per svariati giorni, come una persona “normale” che viene alloggiata nel reparto dei transessuali, come una persona detenuta lasciata dormire una notte in infermeria. Perché non sanno più dove metterli questi detenuti, il cui numero cresce di centinaia ogni mese che passa.
Perché i Tribunali di sorveglianza, soprattutto quello di Roma, non hanno personale (né elasticità mentale) e non riescono a mandare alle pene alternative neppure le persone che hanno tutti i requisiti per ottenere questi benefici previsti dalla legge.
Nel mio reparto c’è Mario, arrestato a 81 anni per una condanna definitiva per reati finanziari di quindici anni prima, che, dopo un mese e mezzo di carcere, finalmente cinque giorni fa si è visto riconoscere dal Tribunale di sorveglianza il diritto ad andare agli arresti domiciliari. Ma, passati cinque giorni, Mario sta ancora qui! Con le sue gambe piene di piaghe e di croste (non so per quale malattia) in bella vista sotto i calzoncini che pure lui deve indossare per sopportare il caldo. Sta ancora qui e nessuno sa il perché!
Ma la politica dorme (con l’aria condizionata), aspettando che il Commissario preposto costruisca magicamente le nuove carceri che dovrebbero ospitare le 14.000 persone che sono detenute in più rispetto a quelle che per regolamento i nostri istituti penitenziari potrebbero ospitare. L’ultima notizia è che saranno acquistate con 32 milioni di euro delle strutture prefabbricate che, una volta installate, dovrebbero ospitare 384 detenuti in più, per un costo di 83.000 euro per ogni detenuto! Considerati i mesi necessari per l’installazione, questi prefabbricati non riusciranno neanche a ospitare le nuove persone che nel frattempo saranno state portate in carcere.
Ma la politica dorme (con l’aria condizionata) e si dimentica delle carceri sovraffollate e surriscaldate, aspettando indifferentemente che la Corte europea dei Diritti dell’Uomo sanzioni l’Italia per trattamento inumano e tortura delle persone detenute. Nel 2024, 71 persone detenute si sono tolte la vita, nei primi sei mesi del 2025, siamo già a 38, un suicidio ogni cinque giorni, numeri che gridano vendetta, ma che non fanno rumore, perché chi muore in carcere, spesso, muore due volte, nella cella e nell’indifferenza collettiva.
Ma la politica se non dorme, fa la faccia feroce “legge e ordine” che dice ai cittadini “puniamo i criminali”, peccato che in questi modo puniscano anche gli agenti di Polizia penitenziaria, seconde vittime del caldo e del sovraffollamento, che girano nell’aria rovente dei reparti, senza neppure potersi togliere di dosso la divisa mimetica.
Certo, fino a ieri a distogliere l’attenzione c’era una nuova guerra che poteva dilagare dall’Iran a tutto il Mediterraneo, ma da qualche giorno i TG parlano solo del caldo che si sta abbattendo su cittadini e turisti.
Sui detenuti no? Problema rimosso, anche giornalisticamente?
Qualcuno mi dirà: ma anche tu dormivi quando eri ministro, o sindaco, o deputato. No, miei cari, io ci perdevo il sonno, facevo riunioni alle tre di notte (chiedere ai poveri poliziotti che mi facevano da scorta), magari non riuscivo a risolvere tutti i problemi, magari non riuscivo a controllare tutto quello che accadeva dietro le mie spalle, ma avevo l’ossessione continua delle persone a cui dovevo dare delle risposte. Perché quando si fa politica, e soprattutto si prendono impegni istituzionali, non si può volgere la testa dall’altra parte, non si può chiudere gli occhi perché non conviene vedere. Perché questo non è solo uno sbaglio, è una vergogna.
Gianni Alemanno.
DIARIO DI CELLA 11: 16 GIUGNO 1979 MUORE FRANCESCO CECCHIN. QUARANT’ANNI DOPO.
Rebibbia, 16 giugno 2025 – 167° giorno di carcere.
Questa volta non vi parlerò del carcere di oggi, vi parlerò del carcere di quarant’anni fa. Come nel romanzo di Alexandre Dumas “Vent’anni dopo”, raddoppiando potremmo scrivere un romanzo intitolato “Quarant’anni dopo”. Il carcere è lo stesso: il Braccio G8 di Rebibbia.
Il 16 giugno del 1979, 46 anni fa, moriva Francesco Cecchin, militante del Fronte della Gioventù di 18 anni.
Era stato aggredito nella notte tra il 28 e il 29 maggio da un gruppo di picchiatori di sinistra e dopo diciannove terribili giorni di coma se ne andò lasciando la famiglia e la comunità militante nella disperazione.
In quel periodo, per la prima e ultima volta della mia vita, io avevo quasi smesso di fare militanza politica per concentrarmi sui difficilissimi studi d’Ingegneria all’Università di Roma. Ma quando la notizia del coma di Francesco si diffuse, ruppi gli indugi e mi precipitai nel Nucleo del FdG del Trieste Salario di cui Francesco faceva parte.
Dato che la realtà dell’aggressione veniva negata dalla stampa dominante, per accreditare invece la tesi di un incidente, insieme a Flavio, il capo politico di quel Nucleo, ci dovemmo impegnare in un piccolo capolavoro di controinformazione politica. Raccogliendo tante prove e tante testimonianze, dimostrammo al mondo che Francesco non solo era stato aggredito ma era stato gettato esanime da un balcone condominiale. Omicidio volontario, compiuto per mano di militanti comunisti con cui Francesco aveva avuto più di uno scontro, per il quale nessuno ha mai pagato per la “negligenza” con cui furono condotte le prime indagini. Parola della Corte d’Assise di Roma.
Quella perdita di un “camerata” di appena 18 anni, quella rabbia per non aver ottenuto giustizia, furono la spinta drammatica per far decollare la lotta militante mia e dei ragazzi di quella comunità. Cominciarono anni turbolenti, il culmine degli “anni di piombo” vissuti in un quartiere di frontiera tra “zone nere” e “zone rosse” dove lo scontro politico violento era all’ordine del giorno. E cominciò anche la tradizione di ricordare Francesco con una veglia notturna a Piazza Vescovio negli anniversari della sua morte, veglie a cui nel corso degli anni partecipò tutto il mondo della destra militante romana, persone che avrebbero smesso di fare politica, o che sarebbero morte in carcere come Nanni De Angelis, o che avrebbero continuato a fare i semplici militanti, o che sarebbero diventati parlamentari e ministri della Repubblica.
Arrivò poi l’orribile strage di Bologna del 1980 che insieme alla morte di 85 persone portò a vastissime retate poliziesche che spazzarono via tutto il mondo militante di destra di Roma. Io e i ragazzi del Trieste Salario fummo uno dei pochissimi nuclei militanti ad essere risparmiati da quelle retate. Ma la voglia di mantenere alta la nostra bandiera nonostante fossimo ridotti a quattro gatti, ci portò ad estremizzare il nostro impegno.
Fino alla notte dell’antivigilia di Natale del 1982 quando, per protestare contro il colpo di Stato comunista compiuto in Polonia dal Generale Jaruzelsky per reprimere la rivolta di Solidarnosc, lanciamo delle bottiglie molotov contro l’Ambasciata dell’URSS e fummo arrestati. Giampiero nel carcere di Regina Coeli. Io, Francesco, Adriano e Paolo Di Nella a Rebibbia, nel Braccio G8, forse – non ne sono sicuro – nella stessa cella in cui sono oggi.
La mia carcerazione durò 10 mesi, poi in appello la mia condanna fu ridotta a 8 mesi e uscii, dopo essere stato eletto, mentre ero in carcere, Segretario romano del Fronte della Gioventù, l’organizzazione giovanile del MSI.
Ma il nostro romanzo non si era concluso. Cinque mesi dopo la nostra scarcerazione, uno dei miei compiutati, Paolo Di Nella di 19 anni, fu di nuovo colpito da una sprangata alle spalle mentre attaccava manifesti al Trieste Salario e, anche lui dopo sette giorni di coma, morì il 9 febbraio 1983.
Paolo era veramente un fratello, l’unico che in tutti quegli anni terribili mi era sempre stato a fianco. Me lo ricordo in cella, mentre un altro detenuto politico più grande cercava di convincerlo ad abbandonare l’impegno politico al mio fianco, scuotere la testa in senso di diniego, accarezzandosi i baffi come faceva quando voleva ostentare il suo carattere duro e la sua determinazione, in genere nascosti dietro i suoi tratti ancora adolescenziali.
Ma questa volta la trappola della violenza non ci catturò, nonostante anche l’omicidio di Paolo sarebbe rimasto impunito, in modo ancora più sconcertante di quello di Francesco. Dieci mesi a Rebibbia non erano passati invano, e la nostra risposta militante a quell’ultimo omicidio degli anni di piombo fu non violenta. E, proprio per questo, più pericolosa e dirompente contro i poteri di quella Prima Repubblica che stava cominciando a declinare.
Nasce così la leggenda del Fronte della Gioventù di Roma, la più importante organizzazione giovanile e militante della destra italiana, che si stende come un filo rosso tra quegli anni terribili di sangue, fino ai giorni nostri in cui – nei bene e nel male – gli eredi di quell’organizzazione sono al Governo della Nazione.
Nasce nel nome di Francesco e di Paolo e si saluta, da questa cella che probabilmente è la stessa in cui ho vissuto con Paolo, i vecchi ragazzi che oggi ricorderanno ancora Francesco e il suo sacrificio.
Ubi est mors victoria tua?
La lettera al Presidente del Senato della Repubblica Sen. Ignazio La Russa e al l Presidente della Camera dei Deputati On. Lorenzo Fontana
Signori Presidenti,
ci rivolgiamo a Voi che rappresentate il massimo punto di riferimento dell’attività parlamentare, per far sentire la nostra voce di persone detenute nel Braccio G8 del Carcere di Rebibbia NC. Siamo persone con esperienze molto diverse – una contraddistinta da un pluridecennale impegno politico e istituzionale, l’altra da una lunghissima esperienza carceraria vissuta studiando Giurisprudenza e lavorando come “scrivano” al servizio delle altre persone detenute – ma accomunate dallo stesso impegno per rendere pubbliche le drammatiche condizioni in cui si vive negli istituti penitenziari italiani.
Drammatiche condizioni che stanno esplodendo: nel cuore dell’estate italiana, mentre milioni di cittadini cercano refrigerio tra ventilatori e condizionatori, c’è un’Italia che brucia in silenzio, è quella delle carceri, dove oltre 62.000 persone vivono stipate in celle pensate per meno di 47.000, dove il caldo non è solo un disagio, ma una pena aggiuntiva, dove la dignità umana si scioglie, giorno dopo giorno, tra muri scrostati, letti a castello e finestre sigillate da pannelli di plexiglass.
Mentre le temperature superano i 45 gradi, i ventilatori sono un lusso per pochi, le celle sono camere a gas, le docce funzionano a intermittenza e l’acqua potabile scarseggia, ogni estate si ripete lo stesso copione: suicidi, proteste, appelli, e poi il silenzio.
Nel carcere milanese di San Vittore il tasso di sovraffollamento ha superato il 220%, a Regina Coeli nel cuore di Roma è al 192%, mentre quello medio di tutti gli istituti di pena italiani è del 133% (calcolando non le capienze teoriche, ma i reparti realmente utilizzabili).
Nel 2024, ben 71 persone detenute si sono tolte la vita, nei primi sei mesi del 2025 siamo già a 38, un suicidio ogni cinque giorni, numeri che gridano vendetta, ma che non fanno rumore, perché chi muore in carcere, spesso, muore due volte, nella cella e nell’indifferenza collettiva.
La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha già condannato l’Italia per trattamenti inumani e degradanti, e se le cose non cambieranno rapidamente, il nostro Paese, “patria del diritto”, rischia se subire di nuovo la stessa umiliante condanna.
Prima di Voi ci siamo rivolti al Ministro della Giustizia: sono passati due mesi e non abbiamo ottenuto alcun riscontro, se non la notizia che il Ministero ha predisposto un piano di 32 milioni di euro per l’ampliamento di nove istituti penitenziari mediante l’istallazione di moduli detentivi prefabbricati. Ebbene, questo intervento dovrebbe mettere a disposizione 384 nuovi posti in cella, con un costo medio per detenuto di 83.000 euro: una goccia nel mare, a fronte di un sovraffollamento di più di 14.000 persone detenute.
Oggi ci rivolgiamo a voi, Signori Presidenti, perché riteniamo che l’unica possibilità di dare una risposta immediata, concreta e adeguata a questa emergenza, sia quella di approvare un provvedimento di legge con il concorso trasversale di forze politiche provenienti da ogni schieramento. Non un indulto o un’amnistia per i quali, non solo sarebbe necessaria una maggioranza qualificata, ma bisognerebbe sfidare un’opinione pubblica giustamente preoccupata dai problemi della sicurezza e della certezza della pena.
Pensiamo, invece, a quella che è stata definita la “Legge della buona condotta”, ovvero un provvedimento che preveda una “liberazione anticipata speciale” tale da aumentare lo sconto di pena già previsto quando le persone detenute mantengono un comportamento giudicato irreprensibile dagli Uffici di sorveglianza.
Su questa ipotesi – come il Presidente La Russa ben sa – si sono già svolti degli incontri politici che hanno coinvolto l’on. Roberto Giachetti, che ha depositato una proposta di legge in questo senso, e l’on. Rita Bernardini, presidente dell’Associazione “Nessuno Tocchi Caino”, che sta conducendo proprio in questi giorni uno sciopero della fame per richiamare l’attenzione sull’emergenza carceri.
Ci rendiamo conto che nel frattempo sono intervenuti conflitti internazionali che hanno messo in secondo piano ogni dramma sociale, compreso quello delle carceri, ma adesso – prima della pausa estiva, che coinciderà con il momento peggiore per la condizione delle persone detenute – è necessario dare una svolta a questi contatti politici, mettendo nell’agenda parlamentare l’urgenza di intervenire sulla situazione degli istituti di pena.
Non chiediamo impunità, chiediamo umanità, non chiediamo clemenza, chiediamo giustizia, anche perché nessuna pena può diventare tortura, perché nessuna cella può diventare una tomba, perché nessuna persona mai dovrebbe essere trattata come meno di un essere umano.
Roma Rebibbia, 30 giugno 2025
Gianni Alemanno e Fabio Falbo
da leggere
“DIARI DI CELLA” – La voce denuncia di Gianni Alemanno da Rebibbia