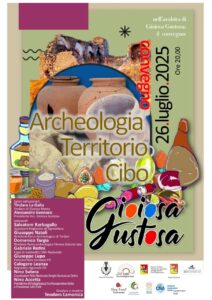“L’integrazione è possibileâ€Â: la scuola è il primo luogo di formazione per una nuova cultura di accoglienza

“L’integrazione è possibile” è il titolo dell’inizia promossa congiuntamente dalla Cisl Messina, dalla Cisl Scuola e dall’Anolf (l’Associazione della Cisl per la tutela dei diritti degli immigrati), che si è tenuta questa mattina all’Istituto Manzoni di Messina, ma è anche il risultato a cui è giunta la ricerca condotta e illustrata dal Prof. Giuseppe Avena sul fenomeno degli immigrati di prima e seconda generazione nella nostra città .
All’incontro hanno partecipato anche gli assessori del Comune di Messina, Magazzù e Caroniti, e Suor Gabriella D’Agostino della Caritas, oltre i rappresentanti della Cisl Scuola, Laura Fleres, e dell’Anolf, Dino Calderone. Ha moderato i lavori, introdotti dal saluto della preside del Manzoni Carmela Maria Lipari, la segretaria confederale Mariella Crisafulli.
La ricerca è stata realizzata nelle scuole medie statali e paritarie del Comune di Messina, aventi tra i loro iscritti almeno un alunno figlio di immigrati di prima o seconda generazione. In tutto sono stati 25 gli istituti coinvolti: Gallo, Galatti, Foscolo, Manzoni, Juvara, Pirandello, Mazzini, Verona Trento, Drago, Petrarca, Pajno, Da Vinci, Pascoli, S. D’Acquisto, Martino, Don Orione, San Francesco, E. da Messina, La Pira, Vittorini, Don Bosco, Sacro Cuore, Leone XIII, M. della Lettera, A.M. di Francia.
“L’integrazione è possibile – ha spiegato il prof. Avena, che ha condotto l’indagine con la dott.ssa Santina Pilato – perché a Messina vi è già un coinvolgimento del contesto territoriale. Non mancano le difficoltà , indubbiamente, ma quelle maggiori sono collegata alla linguaâ€Â.
“In città esistono tante realtà di immigrati – ha sottolineato suor Gabriella D’Agostino della Caritas – noi cerchiamo di sostenere il loro percorso d’integrazione, così come abbiamo fatto con i Rom che, nonostante la differenze di cultura, adesso hanno compreso anche l’importanza del percorso formativo e quindi tanti ragazzi frequentano la scuola. Per noi è stato un grande risultatoâ€Â.
A concludere i lavori è stato il segretario generale della Cisl di Messina Tonino Genovese che ha evidenziato come la scuola, oltre alla famiglia, sia da sempre il primo elemento di formazione delle future generazioni messinesi.
“La ricerca – ha detto Genovese – dimostra come attraverso la formazione scolastica si favorisce l’abbattimento delle barriere culturali, sociali linguistiche e dei pregiudizi. Questo deve essere un ulteriore stimolo a favorire l’integrazione attraverso la formazione che deve coinvolgere i ragazzi in età scolare ma anche gli immigrati presenti sul nostro territorio. Come Cisl – ha annunciato il segretario generale – ci faremo promotori di percorsi di formazione, alfabetizzazione e di crescita anche culturaleâ€Â.
La Cisl ha annunciato che a breve verrà lanciata una nuova iniziativa, SOS LINGUA: la possibilità cioè per gli stranieri presenti nel nostro territorio, attraverso dei numeri di telefono dedicati e che verranno diffusi prossimamente, di poter rivolgersi a connazionali che parlano bene l’italiano per risolvere eventuali problemi di lavoro, salute o per il confronto con le istituzioni.


Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
INDAGINE CONOSCITIVA SUL PROCESSO DI INTEGRAZIONE DEI FIGLI DI IMMIGRATI A MESSINA
Consultando le più recenti rilevazioni dell’Istat, si riscontra che, in Italia, sono quasi quattro milioni gli stranieri regolarmente soggiornanti. Per la precisione gli immigrati residenti nel nostro paese sono 3.432.6511. Un numero pari al 5,8% della popolazione complessiva, contro una media dei paesi U.E. del 5,6%. Gli stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio dello Stato italiano parlano 150 lingue diverse, auspicano di acquisire la cittadinanza e arrivano nel nostro paese con un movimento di massa difficilmente controllabile dai flussi regolarizzati: più di 500 mila nel 2006, con un aumento mai raggiunto negli anni passati, nonostante i provvedimenti di sanatoria adottati. Rispetto ai paesi dell’Europa continentale (Francia, Germania, Regno Unito), che avevano sperimentato già in passato flussi migratori consistenti, l’Italia ha una storia relativamente recente come paese di immigrazione. Proprio per l’estrema rapidità con cui da paese di emigrazione l’Italia si è trasformata in luogo di immigrazione, si è andati incontro ad una difficoltà obiettiva da parte dell’opinione pubblica di valutare correttamente la consistenza del fenomeno e i suoi effetti.
Ciò ha portato ad una radicalizzazione di percezioni e valutazioni sulle conseguenze del fenomeno migratorio che spesso non hanno contribuito a cogliere la complessa e dinamica realtà delle immigrazioni e i suoi molteplici impatti.
Anche sotto il profilo politico c’e stata, e permane, una tendenza a polarizzare la discussione tra fautori e contrari all’immigrazione, tutto ciò ha posto in secondo piano l’esigenza di trovare pragmaticamente una soluzione ad un fenomeno che, come chiarito dai demografi, non può essere evitato e, come conferma l’esperienza di altri paesi con una storia di immigrazioni più lunga e consistente della nostra, se ben gestito può rappresentare un enorme fonte di sviluppo economico e culturale per il nostro paese.
La presente analisi, pur soffermandosi su una tematica che desta già parecchi dibattiti tra gli studiosi, propone caratteri di novità fondati sull’idea di esaminare un segmento particolare all’interno dell’ampia problematica degli stranieri in Italia, ponendosi come obiettivo lo studio del quadro generale e nel contempo dettagliato della situazione dei figli di immigrati (di prima e di seconda generazione) nel contesto territoriale di Messina, andando al di là del semplice conteggio delle presenze nelle scuole medie statali e paritarie della città , ma cercando di esplorare il fenomeno sotto aspetti di tipo prevalentemente qualitativo, per approfondire le diverse implicazioni di un contesto sociale che sta diventando sempre più stabile e strutturale.
La scelta della scuola come punto di riferimento è dettata dal fatto che l’evidenza empirica mostra che, nei complessi processi di integrazione, un ruolo chiave è giocato proprio dall’istruzione dei figli degli immigrati, vale a dire dal processo di formazione e accumulazione del capitale umano, punto di partenza per il successo nel mercato del lavoro e per l’inserimento nella società .
Inoltre, la condizione della seconda e terza generazione è il metro per valutare l’efficacia delle politiche di integrazione: maggiore è la distanza tra la loro condizione e quella del resto della popolazione, maggiore è la probabilità di segregazione ed emarginazione, con gli associati costi in termini di mancato utilizzo di risorse e problemi sociali.
Quello che emerge da numerose ricerche, ma anche dai dati del Ministero, è che i figli degli immigrati faticano a inserirsi nel sistema educativo, mostrando, da una parte, esiti scolastici inferiori e, dall’altra, più bassi tassi di scolarizzazione.
Questo fenomeno è particolarmente grave se si considerano le traiettorie della seconda generazione di immigrati, che, in quanto nati o almeno scolarizzati nei paesi di accoglienza, dovrebbero godere delle stesse opportunità degli autoctoni.
La scuola, dunque, costituisce un laboratorio privilegiato di inclusione sociale, ed è suo obiettivo educare alla convivenza civile e costruire percorsi di integrazione capaci non solo di accogliere, ma anche di valorizzare tutti gli individui, trasformando le diverse provenienze culturali in opportunità di formazione per tutti.
Ai fini della raccolta delle informazioni è stata realizzata un’indagine sulla totalità degli alunni stranieri frequentanti le prime, seconde e terze classi delle scuole medie statali e paritarie del comune di Messina. Tale indagine esclusiva effettuata ad hoc sull’argomento di studio si è sviluppata attraverso le seguenti tre fasi:
•   definizione del disegno di ricerca;
•   costruzione e somministrazione del questionario;
•   immissione ed elaborazione dei dati.
Sono stati rilevati 242 ragazzi stranieri, di cui il 48% maschi e il 52% femmine, distribuiti in un intervallo di età che va dagli 11 ai 18 anni, distribuiti nelle 25 scuole medie, 20 statali e 5 paritarie, ai quali è stato somministrato un questionario formulato sulla base delle informazioni che l’indagine intende catturare, ovvero la qualità della vita dei ragazzi figli di immigrati.
Il questionario è suddiviso in 5 sezioni: una prima sezione inerente i dati anagrafici dei ragazzi; a seguire, una seconda sezione dedicata al percorso scolastico condotto, mirata a conoscere anche l’eventuale scelta di un istituto superiore, nel caso in cui lo studente frequenti la terza media; una terza sezione denominata “Conoscenzeâ€Â, incentrata su informazioni standard riguardo gli anni vissuti in Italia, il gradimento della città in cui vivono, la conoscenza della lingua italiana, il grado di istruzione e la professione dei genitori; una quarta sezione denominata “Tempo liberoâ€Â, la cui funzione principale è quella di conoscere come i ragazzi trascorrono il loro tempo libero, quali sono i loro hobby, ma soprattutto, quanto concretamente si trovano bene con i coetanei italiani, e infine cosa pensano del rapporto italiani-stranieri, percepito secondo tutti i punti di vista. In quest’ultima sezione si ottengono informazioni anche sull’ambiente familiare, ed in particolare, su come i genitori interpretano la relazione italiani-stranieri, e conseguentemente, come viene percepito dai ragazzi. Il questionario termina con la “Sezione famiglia†che ci dà importanti informazioni riguardo la religione professata, il rapporto scuola-famiglia, estrapolato dalla frequenza dei genitori che partecipano alle riunioni scolastiche. Infine, a conclusione del questionario, viene posta ai rispondenti una domanda aperta con la quale si chiede se sono felici di vivere in Italia, specificandone la motivazione.
La costruzione del questionario non si è rivelata un lavoro semplice, in quanto ha richiesto conoscenza ed esperienza nella formulazione dei quesiti. Tale compito è risultato ulteriormente delicato e complesso se si tiene conto del tipo di utenza a cui era destinato. Proprio per queste motivazioni le domande sono state accuratamente scelte prediligendo la chiarezza e la semplicità di esposizione, utilizzando un linguaggio elementare, tenendo conto della probabilità di incontrare ragazzi stranieri che conoscono poco o per nulla la lingua italiana. Infine, è stato dato al questionario un forte impatto visivo, giocando molto su immagini e colori, per catturare l’attenzione. Esso ha assunto pertanto una forma molto comprensibile e di facile interpretazione, ma non per questo priva di quelle importanti tecniche, quali le domande di controllo, finalizzate a verificare la significatività e l’attendibilità di alcune risposte.
L’analisi descrittiva sui dati raccolti ci ha permesso di trarre conclusioni sulla distribuzione per sesso e per età dei ragazzi intervistati, la loro provenienza, la composizione e distribuzione delle famiglie nel comune di Messina, la loro situazione scolastica, il modo di trascorrere il tempo libero e la religione professata.
I ragazzi a cui è stato somministrato il questionario provengono da 29 paesi differenti, anche se la maggior parte di loro è in Italia dalla nascita. Per non lavorare su 29 provenienze differenti, e per dare un quadro più chiaro ed omogeneo di quanto rilevato, è stato utile raggruppare le provenienze dei genitori in 9 aree, rispettivamente Africa, Asia, Italia, Nord Europa, Est Europa, Nord America, Sud America e di seconda generazione di immigrati.
Riguardo la distribuzione delle famiglie nel comune di Messina, dall’analisi effettuata e risultato che la maggior parte di immigrati risiede nella IV circoscrizione, ovvero nella zona centrale della città , dove se ne ritrovano il 41%. Le zone a seguire con una discreta densità di abitazioni di immigrati sono la III, la V e la VI, un bassissimo numero di residenze si trovano invece nella zona sud della città , e dunque nella I e nella II circoscrizione, dove si ritrovano solo il 4% delle famiglie.
Con l’applicazione del G-test si è rilevata la presenza di indipendenza o associazione tra le variabili categoriali “anni compiuti†e “classe frequentataâ€Â, ottenendo come risultato che, nonostante ci sia un forte ritardo evidenziato dalla presenza di un’alta percentuale di ragazzi di 13, 14 e 15 anni frequentanti rispettivamente la prima, la seconda e la terza media, in generale l’andamento del ritardo è alquanto omogeneo, per cui risultano in numero poco rilevante i ragazzi con maggiore ritardo scolastico sparsi tra le tre classi. Tra le analisi realizzate vi è stata anche la costruzione di un indicatore oggettivo di incidenza ed uno soggettivo di integrazione da cui risulta, dopo un esame attento e dettagliato di tre aspetti fondamentali quali la scuola, la lingua e l’ambiente familiare, un grado di integrazione decisamente soddisfacente.
Per esaminare più da vicino tre importanti quesiti del questionario si sono utilizzati i rapporti di probabilità , calcolando conseguentemente gli odds ratio che hanno evidenziato sempre un’associazione positiva. Infine, attraverso il programma T-LAB, specializzato nell’analisi lessico-testuale, si è analizzata una domanda di tipo aperto, posta alla fine del questionario, che ci ha permesso di ottenere interpretazioni accurate di tipo qualitativo.
Il lavoro si è concluso con una breve riflessione sulla religiosità e con il confronto tra i risultati ottenuti attraverso la nostra indagine nella sezione del questionario riguardante la religione e quelli ottenuti dallo studio di M. Barbagli e C. Schmoll, “Sarà religiosa la seconda generazione? Una ricerca esplorativa sulle pratiche religiose dei figli di immigratiâ€Â. Dopo aver fatto una breve distinzione tra la tesi dell’Assimilazione religiosa e quella della Religiosità reattiva, dal confronto delle variabili “Da quanti anni vivi in Italia†e “Partecipi ai riti previsti dalla tua religione†si è riscontrata una religiosità di tipo reattivo, infatti la frequenza ai riti religiosi è tanto maggiore quanto più lungo è il periodo di permanenza in Italia.
prof. Giuseppe Avena
dott.ssa Santina Pilato


Dati Immigrazione
In Sicilia il numero di immigrati è passato dai 24.900 del 1991 agli oltre 114.000 del 2008 e l’incidenza sulla popolazione complessiva è salita dallo 0,5%, al 2,3%, anche se è sempre vero che la Sicilia (e il Sud in generale) rappresentano spesso per gli immigrati una tappa intermedia del processo di insediamento nel territorio nazionale. A conferma di questo gli stranieri residenti in Sicilia rappresentano appena il 2,9% del totale nazionale.
La Sicilia, fa registrare la percentuale più alta di popolazione straniera minorenne di tutto il Mezzogiorno (20,4% del totale degli stranieri). La fascia di età più presente fra i migranti è, tuttavia, quella compresa tra i 18 e i 39 anni che rappresentano il 48,8% del totale. La fascia compresa fra i 40 e i 64 anni raggiunge il 28,4% e quella degli anziani con più di 65 anni si ferma al 2,4%. Questa composizione particolarmente sbilanciata sul versante giovanile porta ad una età media dei migranti residenti in Sicilia di 32 anni a fronte dei 41,3 anni di tutta la popolazione residente in regione.
Più di un immigrato su cinque residente in Sicilia si trova nel capoluogo Palermo che conta 23.812 residenti e registra un incremento del 12,1% rispetto all’anno precedente.
Una quota che, comunque, attesta su un modesto valore di 1,9% l’incidenza degli stranieri sul totale degli abitanti del capoluogo regionale. Stessa incidenza, ma raggiunta con un ben più notevole aumento (+ 20,2%) quella registrata a Catania che è passata da poco più di 17.000 presenze nel 2007 a 20.550 nel 2008. La terza provincia per numero di migranti è Messina con 18.882 presenze e un aumento del 17,8%. Con questi numeri il capoluogo peloritano arriva contare quasi tre residenti stranieri ogni cento abitanti.
In tutti e tre i grandi contesti metropolitani dell’isola è ormai preponderante la presenza femminile. Palermo fa registrare la percentuale di donne più alta in Sicilia (se si esclude la piccola provincia di Enna) con il 57,7% di residenti ed uno dei valori assoluti più alti
del Sud Italia (13.750 residenti). Messina e Catania si attestano rispettivamente sul 55,2% e 55,9%. È il segno che bisognerà imparare a leggere l’immigrazione siciliana con un altro occhio ed uno sguardo più attento ai mutamenti.
A Messina i cittadini neo comunitari della Romania sono in prevalenza donne e l’intera comunità sta insidiando il primato dei cingalesi nella città dello Stretto.
Lavoro. All’INAIL si contano 86.122 occupati netti tra i nati all’estero nel corso del 2008. Una quota che fa salire al 7,9% (+1% rispetto al 2007) la percentuale di mano d’opera straniera impegnata in regione. Un dato che rimane sempre distante dalla percentuale nazionale del 15,5%. Nell’analisi dei dati troviamo pressoché invariata al 36,2% la quota di partecipazione femminile al mercato del lavoro dei nati all’estero. Il maggior numero di occupati si trova a Catania (15.372) seguita da Ragusa (14.432), Palermo (14.136) e Messina (12.766). Il maggior numero di assunzioni si è verificata, invece, nella provincia di Ragusa con 10.276 assunzioni e 9.682 cessazioni. Numeri che si spiegano col carattere stagionale dell’economia agricola della zona. flessibile. I settori che vedono maggiormente impiegati gli stranieri sono quello dei servizi (assorbe il 52,1% degli occupai) che è preponderante a Messina, Palermo e Catania soprattutto per quel che riguarda il commercio e l’impiego in alberghi e ristoranti. A seguire troviamo l’industria (soprattutto quella delle costruzioni) anch’essa molto presente nelle aree metropolitane e
nella provincia di Siracusa e l’agricoltura maggiormente concentrata nel ragusano e nel trapanese.
Scuola. Attraverso i dati del Ministero della Pubblica Istruzione per l’anno scolastico 2008/ 2009 si possono quantificare gli alunni con cittadinanza straniera che studiano in Regione in 16.424 unità con un aumento di quasi 2.000 ragazzi rispetto all’anno precedente Il numero maggiore di scolari è concentrato nella scuola primaria (6.654) dove arrivano a rappresentare il 2,5% degli studenti. Vi sono poi oltre 3.700 iscritti alla scuola secondaria di primo grado, oltre 3.100 a quella di secondo grado e quasi 3.000 alla
scuola per l’infanzia. I contesti che assorbono più alunni in valore assoluto sono quelli di Palermo (3.744), Catania (2.888), Messina (2.631) e Ragusa (2.246). Queste quattro province raccolgono il 70% degli alunni con cittadinanza straniera. In accordo con i dati sulle presenze, la prima cittadinanza presente è quella rumena che si trova distribuita uniformemente in tutte le province con delle punte a Catania, Agrigento e Messina. Il secondo posto spetta alla Tunisia i cui alunni 2.237 scolari sono in gran parte concentrati nelle province di Trapani e Ragusa (69% del totale). A seguire troviamo gli alunni di origine marocchina che sono 1.744 e frequentano soprattutto a Messina, Palermo, Agrigento e Caltanissetta. Altre comunità con una buona presenza di studenti stranieri sono l’Albania (soprattutto a Ragusa e Messina), lo Sri Lanka (nelle tra province metropolitane), il Bangladesh (pressoché esclusivamente su Palermo), le Mauritius (quasi tutti concentrati su Catania) e la Cina (presente in tutte e nove le province).