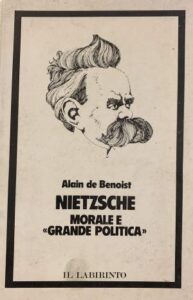L’evoluzione della comunicazione politica nel post mortem ideologico. Il rapporto tra morale e politica
Il rapporto tra morale e politica
L’importanza della comunicazione, problema che attanagliava persino le grandi correnti filosofiche, la paura nel valutare se affidarsi ad una espressione poetica o alla prosa con i pro e i contro che ne conseguivano fu uno dei paradigmi per l’esposizione di un qualsiasi tipo di sapere.
Studi settoriali scuole di pensiero che analizzano i comportamenti dell’individuo e che inevitabilmente si incontrano con la necessità politica, veicolata da quel irrefrenabile bisogno del consenso. Sarà stato un evolversi, o involversi, della capacità comprensiva del popolo?
Sarà stato un ingiusto e poco rispettoso accanimento contro le ideologie? Sta di fatto che non serve l’Istituto nazionale di statistica per comprendere la semplicità di assuefazione di fronte ad una capacità comunicativa elementare ed alquanto spoglia. Il famoso discorso alla pancia, intellettualmente definito come retorica populista, oggi non è più un arrangiamento, ma funge da perno attorno a cui ruota l’attività espansiva. Fa sentire vicini tutti, categorie per anni rimaste inermi alla grandezza intellettuale della politica vista, fino a non molto tempo prima, con occhi contrastanti al tempo stesso, pieni di ammirazione e odio ma sempre con rispettoso distacco.
Non è possibile definire se sia un bene o un male questo coinvolgimento di massa, ma sarebbe ingenuo dubitare, ad oggi, della sua efficacia. Risulterebbe superfluo e banale altresì biasimare chi, di necessità virtù, di questo modello comunicativo ne ha fatto arma principale, chi indistintamente dalla provenienza partitica seleziona un pubblico a cui riferirsi e ne beneficia traendone ogni tipo di vantaggio. A questo va aggiunto il basso cabotaggio dei pochi attori dello scenario politico moderno che non sposano questa idea della retorica populista ma che concretamente per evidenti carenze comunicative, senza voler dubitare di quelle conoscitive, non riescono ad ostacolare il diffondersi di questa usanza.
Il ricorrere a qualsiasi mezzo pur di raggiungere il fine più importante che è il consenso ha spogliato la politica di quella sacralità e di quella serietà che anche nei periodi meno sereni l’hanno contraddistinta. In un noto film che celebra la biografia di Giulio Andreotti colpisce la vicenda in cui un sacerdote ironicamente, analizza il comportamento di De Gasperi ed Andreotti affermando che il primo si recasse in chiesa per parlare con Dio, il secondo per parlare con i preti. Prontamente Andreotti rispose che i preti votano, Dio no.
Gli addetti ai lavori sono un importante tassello nel puzzle della comunicazione. L’accrescersi di un’informazione monopolizzata, di massa ha fatto da complice al divulgarsi del vuoto di contenuto espresso dalla classe politica. La mancanza di critica il centralizzare il nulla rendendolo eclatante ha veicolato l’audience fino a raggiungere un punto di non ritorno.
Posta fin qui la concentrazione in merito a chi osserva questi comportamenti, tocca spostare l’attenzione a coloro i quali questi comportamenti sono indirizzati. Il popolo tutto, si è affievolito dinnanzi a tali atteggiamenti, integrandoli nella quotidianità, rendendoli normalità adattandosi e spesso preferendoli, suscitando un accanimento, inteso come determinazione negativa, nei confronti di coloro che provassero a contrastarli. Proprio questo il nodo cruciale della vicenda. L’odio, il disprezzo per tutti coloro che, non accettando il declino culturale del fenomeno sociale, in qualsivoglia momento e modo opponessero il loro disaccordo è la sconfitta più grande. A tal proposito trovano posto le parole di Vito Mancuso, teologo dei nostri giorni:
“Ciò che auspico è il superamento nella mente dei credenti della convinzione che la verità della loro fede cattolica si misuri sulla conformità alla dottrina consolidata, tanto in campodogmatico quanto in campoetico. Ciò che auspico è l’introduzione nella mente dei credenti di una concezionedinamico-evolutiva della verità e non più statico-dottrinaria”.
Un voler rimarcare l’efficacia della verità come bene e non come dottrina.
Per questi e per molteplici altri motivi il ruolo della comunicazione assume un peso significativo. Definendo oggi la politica come etica della responsabilità, seguendo il concetto di Weber, per la quale non perde mai di vista le conseguenze dell’agire si rischierebbe di incorrere in un ossimoro. Difatti la responsabilità dovrebbe esser garante di quelle conseguenze dell’agire, legato perché no anche al peso delle parole, troppo spesso sottovalutate.
In una visione ottimistica potrebbe definirsi, momentaneamente accantonato il concetto di sapere come mezzo di raggiungimento di consenso, in una visione pessimistica invece bisogna eliminare la parola momentaneamente dal periodo precedente.
Andrea Celi