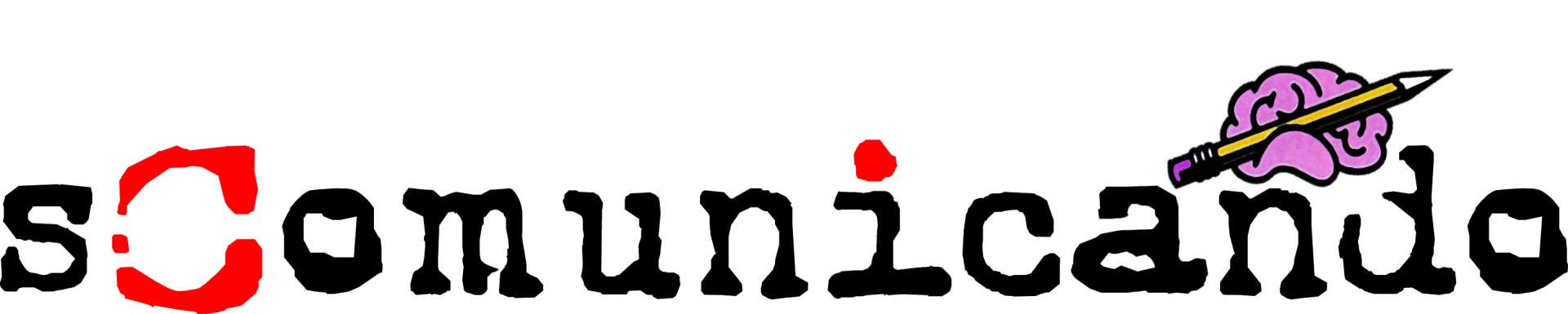Le parole di Alessandro Di Battista, in suo recente scritto su “verità scomode” sollevano un tema di fondamentale importanza: la manipolazione dell’informazione attraverso l’uso strategico delle parole.
“Gli israeliani sono chiamati ‘ostaggi’, mentre i palestinesi vengono definiti ‘prigionieri'”.
Questa distinzione linguistica, apparentemente sottile, in realtà incide profondamente sulla percezione dell’opinione pubblica e sul racconto che i media forniscono del conflitto israelo-palestinese. In questi giorni, le immagini degli ostaggi israeliani liberati hanno occupato le prime pagine dei giornali e i servizi di apertura dei telegiornali. È giusto raccontare le loro storie, ma la domanda che emerge è: perché non viene dedicato lo stesso spazio ai palestinesi detenuti da Israele? Perché questa narrazione a senso unico?
Secondo Di Battista, la scelta delle parole non è casuale. Definire i palestinesi come “prigionieri” suggerisce implicitamente che essi siano in carcere per un qualche crimine commesso, mentre in realtà molti di loro sono detenuti senza accuse formali, senza processo, in quella che Israele chiama “detenzione amministrativa”.
Ad oggi, sono oltre 3.376 i palestinesi reclusi senza motivo, inclusi 320 bambini.
Uno dei casi più emblematici è quello di Khalida Jarrar, parlamentare palestinese di 61 anni, più volte arrestata e recentemente liberata. Per sei mesi è stata costretta in una cella di un metro per un metro e mezzo, in totale isolamento, privata di acqua, cibo e contatti umani. È uscita irriconoscibile, segnata nel corpo ma non nello spirito. Un trattamento che, se fosse stato inflitto a una prigioniera in un altro Paese, avrebbe suscitato indignazione e proteste internazionali.
Ma su Israele si preferisce tacere.
La denuncia di Di Battista non si limita alla questione semantica, ma evidenzia l’ipocrisia di un sistema mediatico e politico che adotta due pesi e due misure. Quando si tratta di Israele, la comunità internazionale chiude gli occhi, mentre altrove le violazioni dei diritti umani vengono condannate con fermezza. Questo silenzio assordante non è casuale: è una forma di complicità.
La riflessione è aperta: fino a che punto siamo disposti ad accettare una narrazione parziale e strumentale?
Qual è il ruolo dell’informazione in un mondo in cui le parole vengono usate come armi per orientare l’opinione pubblica?
In un’epoca dominata dalla comunicazione globale, il compito di chi cerca la verità è quello di rompere il silenzio e denunciare ogni forma di ingiustizia, indipendentemente da chi la commetta.
per leggere l’articolo: