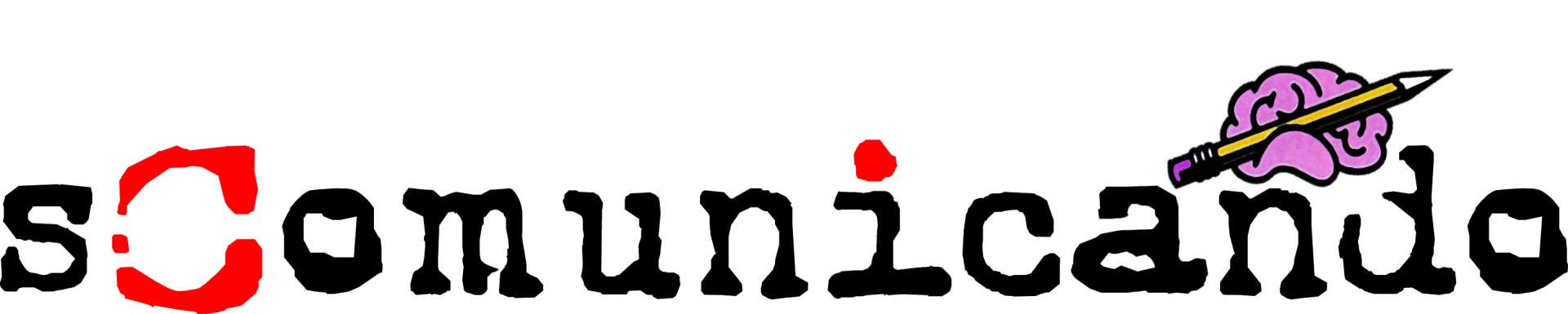L’incontro letterario è promosso da “un’altra storia” e dall’amministrazione comunale gioiosana.
Interverranno, oltre al sindaco Ignazio Spanò, anche Teodoro Lamonica, promotore dell’iniziativa, Emilia Princiotto, presidente della consulta giovanile, Ottavio Navarra, l’editore e la stessa autrice Rossanna Carturan.
—-
Maria Elena, Assunta, Germana, Irene, Peppina, e ancora altre: un vero e proprio matriarcato da affrontare per Margherita, che ritorna tra le mura domestiche di quella grande casa di campagna dopo anni di lontananza, richiamata dalla capostipite di famiglia, che non le anticipa però nessuna spiegazione.
Le vecchie abitudini di punizioni e decotti “ristoratori” non sono cambiate, il rigore e l’acrimonia della nonna Esmeralda non si sono affievoliti col tempo.
L’immaginario infantile di Margherita si ricostituisce e la costringe a rivivere emozioni accantonate, a riappropriarsi di quella parte del passato rimasta in bilico tra verità e leggenda, tra omissione e mistificazione.
Ma non avrebbe immaginato di dover viaggiare con la mente fino alla Francia degli anni ’20 e della poesia di Paul Valéry; di dover chinare la testa ed entrare nelle grotte a oltre 20 metri di profondità in cui le zie si rifugiavano durante la guerra e si divincolavano dalle braccia dei soldati tedeschi; di doversi domandare un giorno: sono figlia di un’assassina?
Rossana Carturan è nata a Torino il 24 agosto 1966 e vive a Latina.
Alcune sue opere sono state pubblicate su riviste letterarie, come Terza Pagina di Sovera Multimedia e Orizzonti di Aletti Editore. Ha vinto alcuni concorsi letterari, tra i quali: “Occhio alla Bozza” (2006), con la raccolta di racconti Sangue di Rapa, edita da Fusta Editore; “… altre poesie d’amore” (2006), organizzato dal Salotto Letterario di Torino; “Racconti nella Rete 2007”, di cui la Newton & Compton Editori ha curato la pubblicazione omonima.
Nel 2009 ha partecipato insieme ad altri autori all’antologia di racconti L’età dello scorpione, edita da Il Caso e il Vento.
Questo è il suo primo romanzo.
QUANDO LE VOLPI SI SPOSANO – ANTEPRIMA: I° CAPITOLO
Incipit
“Quando le volpi si sposano”
di Rossana Carturan
Capitolo 1
Oggi
Il semaforo è rosso.
Gli occhi camminano seguendo un rigagnolo che va a morire al bordo del marciapiede.
Ero seduta lì da bambina, facevo cerchi nell’acqua con un bastoncino, aspettando che mia nonna uscisse da quella casa. A volte il sorriso le rimaneva impresso per ore, a volte aveva lo sguardo indispettito di chi non ha ottenuto quel che cercava. E così mi strattonava fino a casa, maledicendo, tra i denti, tutta l’ultima sua generazione, mentre io continuavo a fissare la pozzanghera fino a perderla di vista completamente. Mi chiesi per anni cosa andasse a fare lì. Non lo seppi mai per certo, forse chiedeva notizie di mia madre a una povera megera, un’anziana guercia che si era improvvisata veggente a pagamento per garantirsi un’entrata economica e sfamare i figli. Tornata a casa, mia nonna radunava le tre figlie e osannava: “Ora è a Torino! Ha detto così!”, e tutte tornavano ai loro lavori di casa, scuotendo la testa.
Un clacson distoglie il pensiero. Un ragazzino in bicicletta mi taglia la strada.
La bicicletta, quante volte, correvo per la salita del colle. “Corri Margherita, corri, vai da zio Armando e ricordati di farti dare anche l’olio!”. Altro che Cappuccetto Rosso, lei almeno aveva un paniere, io buste di plastica, quasi sempre bucate, che dovevo aggiustare lungo la via. Era divertente però, quando al ritorno, carica di cibarie, a occhi chiusi, tra sassi e rami, alzavo le gambe in aria, così da scivolare giù per la discesa molto più veloce. Sembrava di volare, anche se finivo a terra sistematicamente. E tra l’eco delle urla di mia nonna, che in dialetto malediceva quella disgraziata di mia madre, perché morisse dove si trovava, piangevo davanti alle uova frantumate che sarebbero toccate a me, come punizione: tutte insieme e crude.
Un turista mi chiede un’informazione: via Manzoni. È dall’altro lato. Dietro la casa azzurra.
Azzurra era anche la camera di Peppina. La figlia scema di mia nonna. Era sempre rinchiusa lì. Le bussavano e lei per risposta emetteva strani suoni, mugolii che mi tornavano in sogno quasi ogni notte. La sua stanza era anche una dispensa. Si appendevano salami e prosciutti, all’uccisione del maiale. Peppina stava bene, diceva la nonna.
– È fresco, che vuole di più?
Ai piccoli era proibito entrare. Io la spiavo dalla finestra. Correva tutto intorno alla stanza, saltava e bestemmiava, ululando come i lupi delle storie di Zio Paride.
Ha iniziato a piovere. Il ticchettio sul parabrezza provoca un rumore fastidioso.
Proprio come le dita di Assunta, dalle unghie laccate e impeccabili, che tamburellavano tutto il giorno sul tavolo di marmo della cucina. E quando le si chiedeva di smettere, lei rispondeva: “Meglio picchiettare che mangiarle!”. Nevrotica, per eredità. Era la più grande delle tre. Non si sposò mai. Eppure era la bella del paese. Qualcuno malignava che fossi sua figlia. Ma le ingiurie durarono poco. Mia nonna metteva a posto con una sola frase qualsiasi malalingua le potesse levare, anche solo con la parola, la verginità della figlia. Assunta era illibata e la Vergine Santa lo testimoniava, perché, a ogni processione, lei portava il sangue del patrono locale in una teca che stringeva al petto. Se non fosse stata vergine, la Madonna l’avrebbe punita annerendo la sacralità.
Sangue carminio, proprio come il semaforo incantato.
Rosso era anche il mantello dell’uomo che mi portò via da quella casa il giorno del mio settimo compleanno, che scoprii poi appartenere a un alto prelato, parente di chissà chi, che mi condusse a uno dei collegi più rigidi che si potessero sospettare.
– Questo ti serve! Un collegio! – disse mia nonna. – Così non finirai come tua madre!
Germana, la più piccola delle mie zie, singhiozzava, mentre Assunta, con le mani possenti abbottonava il mio cappotto dandomi raccomandazioni di bon ton, neanche andassi a una cerimonia regale.
Germana mi abbracciò quasi a stritolarmi. Per lei andavo incontro alla morte sicura e in qualche modo aveva ragione, il collegio non sarebbe stato una passeggiata. Mia nonna rimase in casa, gli addii le davano urto. Li trovava inutili. A suo dire: le lacrime erano punture del diavolo a ingannare i santi.
È verde.
Mi accosto a un angolo, l’ansia è alle stelle e non riesco a proseguire. Manca ancora qualche ora e la mente torna di nuovo indietro. Fisso un punto lontano e il ricordo si fa sempre più vicino.
Sono passati solo due mesi da quando ho preso la decisione di tornare a casa.
Il ricordo
Il tanfo del canale vicino era nauseante. Il crocefisso al centro del bivio modificava il proprio colore a seconda del cielo. Tutto era immutato. Avevo percorso ore e ore in macchina, senza mai fermarmi. Avevo fretta di ritrovarle.
Arrivai. Il podere aveva perso il colore rosso delle antiche case cantoniere. Sbiadito e scrostato, sembrava dolersi dei malanni della vecchiaia. Accostai di fianco al cancello. Una luce fioca proveniva dalla sala da pranzo. Le zie avevano ereditato dalla nonna anche il suo senso del risparmio, o forse, talmente abituate, non riuscivano più a sottrarsene. Fango, il cane di zia Germana, chiamato così per la sua predilezione allo sporco, era appollaiato davanti all’uscio. Mi vide, tese un orecchio senza scomporsi e riprese il suo sonno.
Misi due dita nell’acquasantiera appesa vicino al ballatoio. Erano ancora lì: le mie chiavi. Un formicolio mi percorse tutto l’avambraccio, come una paresi di ricordo. Un desiderio di fermarmi e tornare indietro. Feci un gran respiro e bussai alla porta. Nessuno venne. Sbirciai dalla finestra, Peppina giocava a tombola da sola, dondolandosi instancabilmente sulla sedia. Il tremolio faceva traballare i ceci sulla cartella. Dalla morte del nonno, non disturbando più la sua vista, le era concesso, durante le festività, di sedere a tavola con le altre.
Una ragazza giovane, mia coetanea, spezzava il torrone nel disappunto di Assunta che, scuotendo la testa, continuava a porgerle il coltello. Doveva essere Irene, la figlia illegittima di Germana. Una storia che si ripeteva all’infinito, che aveva coinvolto quasi tutte le donne della mia famiglia.
Appena nata l’avevano nascosta in casa di alcune cugine del nonno, fino a quando, adolescente, l’avevano portata in casa come trovatella, nel consenso matriarcale.
− Zia fa nulla, posso farlo anche con le mani.
− No, no, no, no…
Difficilmente Assunta avrebbe ceduto. Le guardai le mani. Nelle pieghe rigide di un sole molto severo, mantenevano la grazia innata di una pianista mai affermata, ma così diligente e seria da far credere di esserlo davvero.
Nella penombra, vicino alla stufa in ghisa, vidi un gomitolo di lana danzare ai piedi piccoli e fasciati di mia nonna. Era lì, la centenaria, come osavano chiamarla in paese, a terminare la sua ennesima mantella dagli improbabili colori. Sentii un tonfo nell’orecchio. Non feci in tempo ad avvertirlo che una mano si pose sulla mia spalla.
− Santa Maria Vergine, ma allora sei tu?
Il cuore, ormai fuoriuscito, cadde a terra insieme a me per lo spavento.
L’odore di naftalina delle lenzuola fu un ottimo esalatore per il mio rinvenimento. Aprii gli occhi e me le trovai tutte lì davanti. Vecchia e nuova generazione.
Un bastone picchiettò sul pavimento di legno. Il silenzio scese di colpo. L’andatura claudicante scandiva il tempo che aveva inflitto alla centenaria la sua instabilità. Il varco si aprì. Assunta fece cenno di aiutarla, ma lei con un solo gesto la trattenne dall’umiliazione. Non era più così maestosa. Aveva perso il cipiglio fisso che incuteva timore anche solo a immaginarlo. Una veste di lana nera la copriva dal collo ai piedi. Il luccichio delle perle sempre più pendenti nei lobi ormai stanchi rifletteva sui vetri della finestra tratti del volto sempre più ossuto. Sembrava scricchiolare a ogni passo, come un manichino usurato. Cercai di tirarmi un po’ su, ma la testa cominciò a girarmi violentemente. Ricaddi sul cuscino. Lei si avvicinò nel brusio di tutte le altre. Mi pose una mano sulla fronte e senza scomporsi ordinò a Germana di preparare l’unguento. Tentai malamente di ribellarmi. Mi ignorò, voltandosi e uscendo con il seguito. L’unguento: solo a sentirlo nominare mi destabilizzavo. Era un preparato a base di origano, salvia, peperoncino verde, estratto di calendula e maggiorana, fatto bollire con spine di rose e foglie di alloro. Una cosa orribile. L’odore poteva restare impregnato sui vestiti per diversi giorni, anche lavandoli con cura.
Veniva preparato a ogni nuovo evento, per purificare e scacciare via qualsiasi possibile malasorte. Questo aveva pensato mia nonna vedendomi, che io fossi lì a servizio di nuovi dannati.
Tutto era iniziato perché, qualche anno prima, facendo un lavoro in collegio ben retribuito, avevo regalato loro un televisore a colori. Non ne avevano mai avuti, neanche in bianco e nero, né tanto meno una radio. Così quando arrivò la tv, a detta di mia zia Germana, l’unica che mantenesse con me una minima corrispondenza, la nonna, non essendo donna di “moderne” vedute, sconvolta dal vedere immagini in quella scatola di metallo, si fece il segno della croce, sbraitando: “L’ha presa il demonio!”, e passò i giorni a seguire maledicendo chi mi aveva messo al mondo, perché io ero “come un cane bagnato in chiesa!”, ovvero: l’impossibile! Tutto era tollerabile ma non offendere la profondità cristiana. E questo io avevo fatto regalando la tv: glorificare superficialità e inganno.
Irene vide il mio volto impallidire all’idea di dover essere spalmata come una gallina pronta a rosolare su uno spiedo. Si avvicinò e mi carezzò la guance. Aveva gli occhi color granata, come quelli di Germana, e il naso pronunciato proprio come Eliseo, il suo presunto padre. Le chiesi quanti anni avesse. Ne aveva quindici, anche se ne dimostrava almeno dieci di più. Il viso segnato dal freddo. La pelle arrossata ai bordi dell’orecchio, con una leggera peluria che tentava di salvaguardarla. Mi mise nella tasca della giacca un biglietto. Non ebbi la forza di prenderlo e leggere. Caddi in un sonno profondo e quando mi risvegliai mi trovai ingiallita dalla testa ai piedi, avvolta in una camicia da notte bianca. Potevo sembrare morta. Lanciai un urlo. Accorsero Irene e Germana, che si sedette sul letto, tentando di rincuorarmi. Mi disse che se avessi fatto la brava la nonna avrebbe permesso un bagno anche prima di sera. Questo voleva dire che era passato un giorno intero. L’odore che sprigionavo era fetido. Pregai Germana di convincere la nonna. Sapevo che se avessi osato io, mi avrebbe come minimo disconosciuta. Acconsentì.
Cercai i miei abiti. Avevo un jeans, una camicia e una giacca di velluto scuro. Soavemente Irene mi fece notare che era sconveniente portare pantaloni in presenza della capostipite, e mi porse una delle sue gonne. Avevamo la stessa corporatura.
Ero lì da meno di ventiquattro ore e già non ne potevo più.
Quindici anni sono un’eternità e questo paese sembrava essere fuori dal mondo. Lo era. Controllato quasi interamente da donne che mantenevano integri i loro valori, rifiutando tutto ciò che potesse portare colore.
Frugai nella tasca della giacca. Ricordavo che Irene aveva lasciato un biglietto. Lo trovai e lo lessi. La frase non mi diceva nulla. Era senza senso. Forse solo il delirio di una giovane donna prossima a sbocciare in un paese dalle poche risorse. Lo buttai via.
Dalla finestra della mia vecchia stanza si poteva scorgere tutta la vallata. L’impatto fu forte. Le felci di Assunta, cresciute in proporzioni smisurate, ai piedi del melo, spiccavano di un verde conosciuto solo sui libri di botanica. Il mandorlo di Germana, ancora arido, mostrava fiero l’arbusto, come un vitello ben ingrassato. E poi loro, le ortensie della nonna, che mai avrebbero osato deluderla, timide e pacate, piegate all’ombra della tettoia.
Pensai a tutte quelle madri che ebbero cura di me, senza mai conoscere la mia.
Germana mi distolse dai pensieri, ambasciatrice di un ordine supremo:
– Puoi fare il bagno!
– Alleluia! – le risposi scherzosamente. – Immagino che se voglio l’acqua calda…
– Già…
– Possibile che solo in questa casa non esista un semplice scaldabagno? Dobbiamo scaldare l’acqua nelle tinozze e portarla su per la scala a chiocciola… è ancora così?
– Se vuoi lavarti…
– Non vi capirò mai… Puoi chiedere a Irene se vuol darmi una mano?
– Certo.
Fatto il bagno, mi sentii rinascere.
La cena venne servita nella sala da pranzo. Un brodo vegetale per iniziare e pulire l’intestino e poi ogni ben di Dio. Non fu in mio onore, anche perché ancora dovevo capire se la padrona di casa avesse accettato il mio ritorno, se pur provvisorio e nonostante fosse stata lei a volerlo.
Tanta magnificenza era per un ospite importante. Avevamo a cena niente meno che il sindaco del paese. La nonna aveva indossato anche lo scialle in pizzo nero che Assunta le aveva portato, quarant’anni prima, dal suo unico viaggio fuori dal paese. Viaggio che aveva fatto parlare l’intera vallata per un mese. Chi l’aveva data in sposa al macellaio scapolo di una frazione limitrofa, chi l’aveva fatta sposa di Dio, chi ancora signora di bordello, ma di quelli lussuosi, per via del suo smalto sempre impeccabile e mai guastato dai lavori domestici. Invece Assunta era andata semplicemente a trovare un’amica, conosciuta in collegio, trasferitasi altrove e in procinto di partorire. Quando tornò, Palmira, la proprietaria dell’unico emporio del paese, le aveva detto:
– Se tu fossi strega sapresti cosa dicono di te!
– Lo sono, ballo nuda sul ciglio della ferrovia nella notte di Ognissanti! – le aveva risposto lei con tono acido.
Così, i benpensanti maschi del paese, non più tanto giovani, passavano ogni primo novembre al freddo, appostati tra i cespugli, nella speranza di vederla.
Mia nonna fece segno di avvertire Fiorenza, la nostra ultima domestica, di servire il secondo. Il cenno del capo era inconfondibile. Leggermente inclinato sulla destra, quasi impercettibile, accompagnato dallo sguardo imperiale dei suoi occhi verdi dalle venature marmoree. Scattai in piedi, proprio come allora, quando con lo stesso cenno mi mandava a dormire. Entrai in cucina, Fiorenza non c’era. La chiamai, senza alzare troppo la voce, quando mi accorsi che era in bagno a vomitare. Controllai l’orologio. Mia nonna aveva fatto richiesta del secondo da solo un minuto e mezzo, avevo ancora trenta secondi di autonomia prima di rientrare ed essere sicura che non avesse chiesto spiegazioni per il ritardo. Fiorenza uscì dal bagno bianca come un lenzuolo. Feci finta di non vederla.
– Mia nonna ha richiesto l’arrosto!
Le voltai le spalle, pur sentendomi in colpa per non averle chiesto cosa le accadesse. Tornai di corsa in sala: avevo svolto il compito in tempi perfetti. La serata proseguì serenamente. Il sindaco aveva proposto a mia nonna di vendere una parte del terreno al Comune, quello che fiancheggiava la pinacoteca, così da poterne fare un cinema.
Ovviamente dissentì, e mentre il volto esprimeva tutto il suo disgusto, l’occhio saettava come fossi io l’artefice di tutto e portassi scritto sul petto, a fuoco come un peccato, il cognome dei Lumière.
Arrogante, come solo lei sapeva essere, insisteva con le sue critiche alla nuova generazione priva di moralità, irrispettosa, e dalle idee strambe. Fu lì, in quel preciso istante, che sbriciolò Irene con un sorriso rigido. La ragazza scoppiò in lacrime, lasciando basita me e l’ospite. Eravamo tutte vaccinate verso la nonna, per cui non capii quella debolezza. Chiese il permesso di alzarsi, che naturalmente per discrezione le fu accordato. Nessuno doveva seguirla.
Il sindaco, imbarazzato da quel silenzio funereo che aveva accompagnato Irene nella sua uscita di scena, sputò battute idiote sul tempo e sui carabinieri, dimenticando che il povero bisnonno Angelo era stato maresciallo proprio in quel paese, godendo di rispetto incondizionato. Tre erano le figure che ancora venivano onorate: il medico, il sindaco e il maresciallo. Tentai di salvarlo.
– Ho saputo che lo zuccherificio va a gonfie vele!
– Oh sì, è il nostro orgoglio!
– Mi hanno detto che ha portato lavoro a molti uomini.
Felice, iniziò un’analisi dettagliata della fabbrica e dell’importanza dei posti di lavoro. Mia nonna però non dimenticò le sue battute di dubbio gusto, così alla fine della cena:
– Questa storia del cinema non mi trova affatto d’accordo. Credo sia solo un ulteriore luogo di perdizione.
– Ma donna Esmeralda…
– Donerò invece il terreno all’Arma, così finalmente potranno fare un monumento ai caduti e lo faremo benedire da don Carmine.
– È onorevole da parte vostra, ma… i giovani…
– Ho deciso.
Il nostro paese ne vantava molti di eroi, purtroppo, per cui il sindaco, che avrebbe voluto sopprimersi e cospargersi tutto di cenere, accennò un forzato sorriso di consenso e si congedò.
Temevo quel momento. Il momento in cui restammo sole. Non c’era Assunta, non c’era Germana, neanche Peppina con i suoi strazi a salvarmi. L’avevo di fronte. Eravamo rimaste io e lei.
Uscito il sindaco, tornò nella sala e si sedette in poltrona. Neanche a pensare di fuggirle. La seguii. Scartò una delle sue caramelle al miele, la portò alla bocca con la solita ritualità, e proferì:
– Sai perché ti ho fatta tornare?
– Perché sentivi la mia mancanza – dissi con aria scherzosa.
Fu un grande errore. Gli occhi cambiarono colore, il viso si riempì di minuscole rughe che un attimo prima sostavano agli angoli della bocca quasi per vezzo. Le vene aggrovigliate delle mani sembravano perdere il controllo. La mia risposta insolente aveva alterato tutto il suo sistema cardiovascolare. Per un attimo pensai che le potesse venire un attacco di cuore, poi come d’incanto tornò tutto alla normalità. E io ripresi a respirare.
Mi fece cenno di andarmene. Aveva lo stesso sguardo accigliato di quando, messa in punizione nella mia stanza per aver disobbedito a una delle mie zie, mi vietava di scendere oltre il settimo gradino della scala a chiocciola. Non me lo feci ripetere e corsi via senza neanche piegarmi.
Dormii tra i gemiti di Peppina e i guaiti rauchi di Fango. L’incubo vero sarebbe giunto il mattino dopo. Dovevo avvisare la famiglia che di lì a qualche giorno sarebbe arrivato anche Giorgio, il mio fidanzato.
Mi svegliai tardi. Imperdonabile. Erano tutte in cucina dedite alla preparazione del pranzo. Germana aveva messo da parte delle ciambelle. Mi fece un caffè. Nonostante fossi ancora intontita dal sonno mi accorsi che Irene non era presente. Domandai alle altre ma non ebbi risposta. Questo stava a significare che dovevo tacere. Non che mi importasse più di tanto, ero solo mossa da curiosità. L’ultima volta che l’avevo vista era in lacrime.
Assunta preparava le varie salse. Era domenica, e come ogni domenica da sempre, per tradizione secolare, la pastasciutta veniva condita con salse tutte diverse e non rosse. Non si doveva dare l’idea, nel giorno del Signore, di mangiare oltre il dovuto, utilizzando il colore del sangue per condire. Per cui una portata piena di piccole cose risultava meno disonorevole di un piatto traboccante rosso vivo. Germana, invece, si occupava del camino e della brace. Rigorosamente pesce, in tutte le soluzioni. Peppina avrebbe mangiato con noi. Ci avvicinavamo al Natale e quindi ogni domenica era una festa.
Irene fece capolino in cucina ancora in pigiama, ed era quasi mezzogiorno. La nonna esigeva che a quell’ora tutto e tutti dovevano essere pronti e a tavola. Se si mancava all’appello, la ragione doveva essere buona o per una settimana lei avrebbe tolto la parola e non solo. Il silenzio era terrificante ma ancor più i castighi. Accadde solo una volta che, distrattamente, avevo lasciato aperto il cancello del pollaio di sera. Quando, la mattina seguente, lei si svegliò, trovò una delle galline che pigolava sotto la tettoia. Venne da me in silenzio, porgendomi un coltello. Il messaggio era chiaro: dovevo ucciderla, spennarla, cavarle le budella e farla bollire senza mai perderla di vista fino al pranzo. Per una settimana mangiai gallina senza diritto di replica e conforto da parte di nessuno. Irene rischiava e forse lo sapeva. Era contrita. Assunta le diede un ceffone forte e la trascinò a forza sotto il lavandino.
– Lavati la faccia. Chissà che queste idee malsane ti abbandonino!
– Ma che succede? – chiesi confusamente.
– Vuole andare alla televisione! – rispose Assunta quasi strozzandosi per la vergogna.
Ci misi un po’ a capire, poi fu chiaro. Irene voleva partecipare a uno di quei quiz televisivi dove per fortuna e bella presenza si potevano vincere parecchi soldi. Era chiaro che la famiglia non le avrebbe mai dato il consenso. Non demordeva, sperava in cuor suo di spuntarla. Forse il biglietto che mi aveva lasciato nella tasca era una metafora per avere la mia complicità. Cercai di trovare un nesso, ma nulla. Lasciai perdere, tanto era inutile provare a capirle.
Assunta si levò di dosso la vestaglia da cucina e la mise a Irene, le arrotolò i pantaloni del pigiama e le aggiustò i capelli con le mani. Potevamo andare a tavola, la nonna non aveva più la vista aguzza, l’avrebbe bevuta.
Dopo il rituale, in cui benedicevamo ogni cibo della tavola, la nonna diede un ordine:
– Andate a prendere Peppina.
– Sì, vado, speriamo non mi tocchi fare tutto da capo! – disse Germana, correndo verso la stanza azzurra.
Ogni domenica mattina, dopo la colazione, andava nella sua stanza a lavarla, pettinarla, profumarla, così da renderla presentabile per il pranzo, ma sistematicamente, quando tornava verso mezzogiorno, la trovava seminuda e in preda a una crisi isterica. Quella mattina no. Restammo tutte sorprese nel vederla sistemata, oserei dire bella. I suoi capelli rossi, lunghi, leggermente crespi, le donavano un’aria sbarazzina, aveva quasi settant’anni eppure la sua pelle era luminosa, forse perché mai contagiata dalle impurità esterne. Era docile, sottomessa. Si sedette senza fare capricci. Composta prese il cucchiaio e cominciò a mangiare. A metà pranzo venne colta da malore e la faccia le cadde nel piatto. Irene emise un urlo dallo spavento, Assunta chiamò il medico al telefono e io e Germana tentammo di rianimarla. Il cibo le colava dalla bocca con un colore verdastro. Fu inutile. Morì alle 13 del 13 dicembre.
“Un funerale è di sicuro più faticoso di un matrimonio. La vita terrena ha dubbi perpetui ed è impura, l’aldilà è la promessa della perfezione e per questo la dipartita deve essere impeccabile”, questo disse mia nonna al funerale del marito e questo ribadì quella mattina.
Obbedienti come bravi soldatini ci dedicammo a scegliere un abito adeguato per la veglia, non per noi, ma per Peppina, all’emporio di Palmira. Assunta era andata dal fioraio, così mentre Germana controllava minuziosamente asole e bottoni della camicetta prescelta, le sussurrai all’orecchio del mio fidanzamento.
– Santa Maria Vergine, tua nonna lo sa?
– No, sei la prima!
– E perché proprio io?
Lo disse con voce tremante. Sentiva il macigno della responsabilità. Non poteva dare consensi né benedizioni. Era difficile spiegarle che anche se avessi avuto critiche non avrei ceduto. Dovevano accettarlo e basta. Rimandai l’annuncio a dopo il funerale. Uno sgarbo così non me lo avrebbero mai perdonato. Per cambiare discorso feci una battuta sulla somiglianza tra lei e Irene. Infelice idea. Il volto si scurì. Il mio eccesso di confidenza fu salvato dall’arrivo di don Carmine. Quindici anni passano per tutti e anche in lui, con il suo riporto color crema, il viso rubicondo maculato di efelidi sempre più insistenti e l’occhio miope sforzato da minuscole lenti. Lo abbracciai e baciai come uno di famiglia.
– Don Carmine! Ma che bello rivederla!
– Che fai? Mi dai del lei? Suvvia… ti conosco da sempre… – mi squadrò. – Sei diventata così grande… – e nella commozione mi strinse in un abbraccio.
L’odore di tabacco misto a una colonia alla lavanda era rassicurante: mi faceva sentire a casa.
Don Carmine aveva 50 anni, la stessa età di mia madre. Erano stati compagni di scuola. Si conoscevano bene e quando lei sparì l’unico che fosse a conoscenza della verità sulla sua scomparsa era lui. Tutto il paese sapeva della loro complicità, anche se negava ostinatamente. Lo avevo perdonato. Ingenuo e fedele.
Si asciugò le lacrime e borbottando ci accompagnò a casa. I preparativi erano tanti e anche lui ebbe la sua parte. Quando arrivammo il cortile era pieno di fiori. Assunta aveva svaligiato una serra. Rose, begonie, margherite multicolori e varie stelle di Natale avevano coperto il vialetto di ghiaia. Più che un funerale sembrava il giubileo della floricoltura. Naturalmente nessuno osò contestare tanta abbondanza. Assunta aveva anche scelto il feretro e gli oggetti che la povera Peppina doveva portare con sé. La collana di perle, regalatale ai suoi 18 anni, il breviario del nonno, una campanella d’ottone e due castagne. L’epigrafe toccò invece a Irene. La disposizione data dalla nonna era che fosse semplice e che non riportasse l’età della defunta. Nessuna delle sue figlie doveva essere oggetto di scherno né tanto meno si doveva dare la possibilità di risalire agli anni della centenaria.
L’iscrizione tombale era in latino, per avere la certezza di essere compresa solo da pochi e sbalordire i più.
Ora non restava che preparare il pranzo e la cena a cui avrebbero partecipato gli intimi, che voleva significare don Carmine, zio Salvatore, fratello del nonno, zia Potenziana, cugina carnale della nonna, e Rosa, sua amica fedele. Il menù: semplice ma importante. Solo Germana, con il suo spiccato senso della misura e con l’aiuto di Fiorenza, poteva far fronte a tale incombenza. Agnello, frattaglie, agnolotti fatti a mano, verdure fresche.
Dei piccoli pasticcini, accompagnati al rosolio e al vermouth, furono offerti ai visitatori a fine pasto. La nonna rimase nella sua stanza a ricevere le visite di condoglianze. La notte si presentava lunga, interminabile.
Alcune vicine di casa, le solite, eternamente nubili, offertesi volontarie come prefiche, approfittavano dei funerali per mostrare le loro arti attoriali, così da impressionare, nel gesto estremo della disperazione, qualche scapolo recidivo e sperare di commuoverlo.
Tra pianti, urla e qualche bicchierino di più, arrivammo a mattina.
La chiesa fu addobbata a dovere. Le file di panche erano state posizionate da Germana in modo da accogliere il paese intero.
Dopo l’arrivo della bara, mia nonna fece la sua entrata trionfale. Nessuno ebbe il coraggio di sedersi prima che lei decidesse in quale sedile accomodarsi. Quando finalmente si collocò, la sala si assestò e don Carmine sparse l’incenso ovunque, a segnare l’inizio della funzione.
Come ogni funerale che si rispetti, anche questo fu accompagnato da una pioggia incessante. Il cielo sembrava voler sputare ovunque la sua rabbia in difesa di una creatura da sempre lasciata alla rovina. Peppina fu il castigo di mia nonna. La centenaria si era sempre vantata che le sue figlie fossero pinze per non scottarsi, ma una sola l’aveva marchiata con un’ustione indelebile: Peppina la pazza.
I primi segni di squilibrio, a detta delle zie, li aveva avuti prima ancora dell’adolescenza, quando l’avevano trovata che vivisezionava, con una limetta per le unghie, Lorena, la gatta di casa. Lorena era “la gatta” per eccellenza. Veniva servita e ossequiata più di un cristiano. L’aveva portata in casa mio nonno come dono alla moglie per la nascita di Peppina. Piccolissima, più o meno due settimane, quasi la stessa età della bambina. Crebbero in una simbiosi allarmante. Le trovavano spesso a dormire insieme nella cesta oppure a mangiare nella stessa ciotola. La nonna non potendo tollerare oltre, tentò di separarle. L’insofferenza al distacco portò Peppina a rivoltarsi ferocemente contro tutta la famiglia. I dispetti si trasformarono pian piano in veri e propri atti selvaggi, finché un giorno Peppina, intenta a incendiare la stalla dei vicini, vide Lorena sbucare da una balla di fieno in un miagolio straziante e con il pelo carbonizzato.
Quando tutti accorsero, attratti dal fumo, trovarono Peppina sdraiata nel fienile che incideva con la lima l’addome alla gatta per portarle via il cuore. Subito dopo la guerra, la sua situazione precipitò, la rinchiusero nella stanza azzurra dove rimase per quasi sessant’anni.
L’estremo saluto a conclusione della liturgia lo rivolse Assunta con un salmo scelto da lei. La bara fu portata via dai quattro figli di Palmira. Il corteo proseguì a piedi fino al cimitero.
Il paese, per rispetto della conterranea, avrebbe mantenuto il lutto per una settimana. I negozianti, gli artigiani tutti si unirono nel cordoglio: era un evento e come tale doveva perdurare.
Un arcobaleno tra le colline accompagnò il ritorno. Aveva qualcosa di familiare eppure non riuscii subito a mettere a fuoco. Ogni volta che appariva un arcobaleno, mi vedevo bambina china su una pietra e un gran brusio di voci intorno. Ancora una volta l’immagine non mi condusse a nulla di nuovo. Pensai che forse non era altro che un incubo che seguitavo a portarmi dietro, perdendo la speranza di capire.
Il silenzio mi distolse. I lamenti di Peppina, un benvenuto malato, annunciavano sempre il nostro rientro. Quel giorno tutto tacque e l’iride si dissolse dietro di noi.
La nonna non avrebbe mai più parlato di quella figlia sventurata, né avrebbe permesso ad altri di farlo. Morire significava fine, estinzione, desolazione, inutilità. Questo era il vero significato dell’assenza per lei. Tutto il resto era superfluo.
Germana, asciugandosi il volto bagnato dalle lacrime, entrò nella stanza azzurra per iniziare a raccogliere tutto quello che riguardava la sorella, ovvero eliminare ogni sua traccia.
– Diamoci da fare! – fece un gran sospiro e aprì le finestre.
Con soggezione entrai anche io. Le mie occhiate risalivano a momenti rubati dietro a una finestra, angoli che non riconobbi quando me la trovai davanti, tutta, immensa, piena di oggetti dalle forme curiose, di disegni sui muri. La mancanza di rumori era sempre più inquietante.
– È incredibile… – dissi appena entrai.
Prendemmo degli scatoloni e cominciammo a imballare. Trovammo pagine di libri, tutte accatastate da un lato in un solido assetto. Fili di lana che intrecciavano una sedia e il tavolo, figurine adesive incollate ai bordi di un armadio, nove spazzole fabbricate artigianalmente e altrettanti specchi bruniti di dimensioni diverse. Mi muovevo nella stanza come fossi una ladra, spaventata dal poter fare il minimo rumore o danno. Perlustrai ogni centimetro di muro. Disegni di arcobaleni si ripetevano all’infinito, in incastri particolari, quasi a definire un percorso. Un labirinto che terminava in un pensiero. Gelai. La stessa frase che Irene aveva scarabocchiato sul biglietto lasciato nella mia giacca:
Quando le volpi si sposano
Questa era la frase di Irene e questa la scritta sul muro incisa da Peppina. Sapevo quando accadeva e ne conoscevo il significato: ignoravo solo cosa potessi entrarci io in tutto questo.
Nell’ultima riga dell’arcobaleno, la più nitida, quella che colpisce la vista, sia essa azzurra o verde o gialla, al bivio con la terra dove lo specchio rimanda l’altro semicerchio, così da creare un tondo immaginario, proprio lì tra i canti sgraziati delle streghe: le volpi si sposano. Quando le volpi si sposano qualcosa di straordinario, bello o brutto che sia, avviene a chi lo intuisce.
Questo si narrava, questo era, anche se sfuggiva ancora al mio sentire.
Rifiutai il pensiero. La testa mi doleva, volevo che la giornata finisse prima possibile e poi con calma avrei esaminato tutto e chiesto spiegazioni a Irene.
– Non ce la faccio più… esco – dissi, in preda a un lieve panico.
– Tranquilla, qui finisco io.
– Grazie, non mi sento molto bene.
Uscii e mi sedetti un po’ sugli scalini davanti al portone di casa.
Pensai a Giorgio, che sarebbe arrivato dopo due giorni, dovevo avvisarlo della morte della zia e chiedergli di tardare ancora. Quando lo chiamai al telefono acconsentì con gioia: poter rimandare l’incontro fatale lo rasserenava. In ventiquattr’ore avrei preparato il terreno e sperato nella complicità di Germana.
Nel pomeriggio presi la bicicletta e feci una corsa in paese. Desideravo schiarirmi le idee e magari finalmente arrivare a comprendere. Se fossi riuscita a ricostruire il periodo buio, avrei trovato ciò che da quindici anni disperatamente cercavo in una ossessione schiacciante. Pochi erano i ricordi da bambina, la memoria non scendeva al di sotto dei miei sette anni.
Arrivata, andai nell’unico luogo pubblico: il Caffè di Miranda. Si chiamava come la proprietaria, nostra cugina alla lontana, considerata puttana e per questo ignorata dalla stirpe. Tre figlie, tutte come lei, rosse, lentigginose e nevrotiche, gestivano il caffè frequentato per lo più da occasionali visitatori, turisti mal capitati e giovani disperati con sogni di fuga.
Presi un tè nella commiserazione della cugina che mi scrutava scuotendo la testa. Dovevo avere un brutto aspetto, vista l’espressione sgradevole impressa nel volto di lei. Forse ero solo simbolo di una memoria da dimenticare. Raschiai i pensieri, tutti quelli che impedivano il collegamento al passato. Brancolavo, non c’era luogo dove io potessi serenamente riaffacciarmi su quello che avevo perduto e che faticosamente tentavo di riprendere. Pensavo che se fossi stata lontana dalla casa e dai suoi componenti sarei riuscita a riordinare la sciarada dell’infanzia. Perché di un rompicapo si trattava.
Mentre scrivevo appunti su un foglietto, me la trovai davanti.
Enorme, austera come una belva sazia, spietata come una baionetta francese, impassibile come una guardia di frontiera. Deglutii l’ultimo sorso quasi strozzandomi. Non c’era famiglia che non raccontasse aneddoti sul suo conto. Un mito da disimparare, oscuro come un film muto dai sottotitoli minacciosi. Feroce nei suoi movimenti lenti, dura nelle sue sillabe concesse come flebo in endovena. Assolute e indiscutibili.
Era proprio lì, Diamante, la sorella di mia nonna.
In frazioni di secondo, gli occhi, partendo dai piedi fino a raggiungere la crocchia cinerea tenuta su da spilli d’osso, sezionarono ogni millimetro di pelle, prima di riuscire a staccarsi e a offrirmi la forza di alzarmi per salutarla con un accenno imbranato delle spalle.
Si sedette senza scomporsi.
Rimasi in piedi finché non aggiunse: – Non sopporto guardare dal basso.
La assecondai. Ordinò una tisana alla menta, mentre accendeva la sigaretta facendosi fuoco con la precedente. Da sempre, usava solo un cerino al mattino e lo lasciava nel posacenere, in bella vista, così che i suoi figli notassero che lei era lì, presente, vigile imperscrutabile di ogni azione, di ogni pensiero sbagliato.
Era proprietaria dei due terzi del paese. Si muoveva tra il lecito e l’illecito. La sua passione erano le corse di cavalli clandestine che anche lo stesso sindaco conosceva e tollerava per non averla contro. Non aveva mai fatto male a nessuno, fisicamente, ma l’idea che potesse farlo era più atroce della possibile azione. Era la più giovane delle nove sorelle. Venti anni di differenza con mia nonna. Aveva ancora un marito, con un ruolo indubbio: essere il consorte di.
Dopo aver fumato due sigarette in silenzio davanti a me, mentre io tentavo poco convinta di chiederle di Vera, la prima figlia femmina, emigrata in Inghilterra nella speranza di conquistare una vita agiata, e finita poi a fare la cameriera in un bar notturno, osannò:
– Devo parlare con tua nonna.
Se avesse chiesto: “Margherita lanciati con il paracadute per me”, sapendo che soffro di vertigini, oppure: “danza sul tetto nuda in una notte polare”, o ancora: “sparisci!”, sarebbe stato meglio. Ottenere un appuntamento con la nonna era la cosa peggiore che potesse chiedermi. In casa non sarei mai riuscita a dire il suo nome per intero senza che la famiglia non avesse già fatto i miei bagagli.
Si rese conto di quel che aveva preteso, così mi diede un buffetto sulla guancia a sfidarmi. Un orgoglio maledetto circolava nelle vene di tutte noi, lo stesso che mi portò a rispondere:
– Certo. Quando? – lo dissi e me ne pentii nello stesso istante.
Sorridendo del mio imbarazzo, sotto la peluria grigia che nascondeva le labbra sottili continuò:
– Ho bisogno di vederla prima possibile. Può farmi sapere lei dove e quando.
– E il motivo… se posso?
– Lei sa.
Ripresi la bicicletta, intontita, come avessi subito uno choc. Ero andata lì per distendermi e tornai devastata.
Era buio ormai. La camera della nonna e la cucina erano illuminate. Quando entrai trovai solo Assunta davanti alla tv a rifarsi lo smalto. Sulla porta sentii lo stomaco prendersi a morsi, la testa pulsare e le gambe in preda a una crisi nervosa. Sbottai malamente:
– Ho visto Diamante!
Assunta non fece una piega. Con la mano scacciò una mosca dal tavolo e continuò a laccarsi le unghie. Mi avvicinai e glielo ripetei all’orecchio.
– Ho… visto… Diamante.
– Non sono sorda.
Era chinata, intenta nel suo operato. Non sapevo cosa pensare. Da sempre non si poteva nominare né lei né la sua famiglia senza che accadesse il finimondo. Si erano forse placate le acque e io non lo sapevo? Sollevata, me ne andai a dormire, pensando che l’indomani più serenamente avrei potuto dare l’ambasciata della tanto temuta. Dopo qualche minuto Assunta entrò nella mia camera. Il volto era cambiato: severo, in attesa. Non c’era bisogno che parlasse, mi era solo sembrato strano che poco prima non avesse voluto sapere altro e così la anticipai.
– Vuole un appuntamento con la nonna, non so altro.
Si lasciò cadere sul letto, come una sconfitta.
– L’ho vista in chiesa, era sulla porta, non credo che tua nonna se ne sia accorta. Ho subito immaginato che non doveva trattarsi di un omaggio alla defunta, ma non sospettavo che la cercasse.
– Hai idea del perché voglia vederla?
Assunta restò per qualche istante in silenzio, poi chiuse il discorso.
– No. Non lo so… e credo che comunicare ora a tua nonna che Diamante la cerca non sia una buona idea, le può venire un colpo per eccesso d’ira, forse è meglio ignorare.
– Ma anche rifiutare non credo sia una buona idea. Sai cosa potrebbe fare Diamante?
– Già, tu non te ne preoccupare, ci penserò io.
La risposta di Assunta non mi convinse affatto. Ne parlai con Germana e lei concordò che la miglior cosa era prendere tempo e poi magari trovare un motivo.